L'Associazione Le Città Visibili in visita a Sant'Agata del Bianco, il paese di Saverio Strati




28 giugno 2025 08:55
Nella luce accecante di una mattina d’estate giungiamo a Sant’Agata del Bianco, dove ci accoglie la nostra formidabile guida Alessandra Moscatello che ci introduce nelle bellezze di questo paese che sta vivendo, da circa sette anni, una meritata rinascita grazie all’entusiasmo e alla determinazione di un ristretto numero di persone, in primis del sindaco Domenico Stranieri, che spesso nel tour accompagna personalmente i visitatori. L’origine del borgo è legata a suggestive leggende medievali. Secondo la tradizione la statua di Sant’Agata fu ritrovata nel XIV secolo in una località aspromontana, Rungia-Litri, e portata lì dai monaci basiliani. Contesa da pastori e cacciatori della zona, si decise di aggiogare la statua ad una mandria di buoi lasciati liberi di muoversi, scegliendo come destinazione il luogo in cui si sarebbe diretta, individuato, poi, nel villaggio di Sant’Alasia; in un determinato punto, si dice, i buoi si inginocchiarono e il villaggio da allora mutò il suo nome in quello di Sant’Agata. Si racconta che il 5 febbraio del 1783, giorno in cui si celebra la Festa della Santa, mentre i fedeli erano in chiesa ci fu il terribile terremoto che devastò molte città e una trave, che cadendo stava per colpire un gruppo di fedeli, si fermò sul braccio della Statua, evitando una strage. Dal murale dedicato a Sant’Agata parte il nostro tour; l’immagine la rappresenta con la palma e la tenaglia, rispettivamente simboli del suo martirio e dell’arma con cui venne torturata.
Ci raggiunge, per darci il benvenuto, la vicesindaca Eugenia Mesiano che ci illustra brevemente il progetto di rinascita del paese: dissotterrare la storia dimenticata e riqualificare, fondendo urbanistica e arte, questo interessantissimo luogo, che oggi è diventato il simbolo di un impegno di pochi e che ha dato il via a un processo di promozione e rilancio di un borgo che rischiava l’abbandono e la totale cementificazione. Oggi, le sue strade sono ravvivate da storie, colori, dettagli e curiosità che stanno contribuendo a far conoscere i suoi tesori: il “Museo delle cose perdute”, ideato dall’artista locale Antonio Scarfone che ha raccolto oggetti di diversa provenienza, epoca e categoria e che rappresentano l’identità del borgo; la Casa-Museo di Saverio Strati, su cui lo scrittore stesso è ritratto con alcuni dei suoi libri più famosi alle spalle e al cui interno una serie di pannelli fotografici, locandine e articoli di giornale, vanno a ricostruire tutta la sua storia e la sua carriera; il Museo Artisti Santagatesi, che custodisce le opere dei tanti artisti nati in questo borgo: Antonio Scarfone, Vincenzo Baldissarro, Domenico Bonfà in arte Fàbon, Alba Dieni, Antonio Zappia, per citarne alcuni. A Sant’Agata, negli ultimi anni, è nato anche un festival di letteratura e musica, che si svolge annualmente nei mesi estivi: Stratificazioni. Continuiamo la nostra passeggiata e Alessandra ci mostra Palazzo Franzè (famiglia di religiosi e artisti), acquistato ai primi del ‘900 dalla famiglia Sgabelloni (Pietro Sgabelloni, trasferitosi a Roma, fu grande amico di D’Annunzio e divenne un importante giornalista nonché vicedirettore de “Il Giornale d’Italia”) e Palazzo Franzè, situato nella Rugarandi, con il suo blasone sul portale. Qui si riunirono Rocco Verduci, uno dei cinque martiri di Gerace, ed i suoi seguaci, per la famosa rivolta che lo condusse alla morte il 2 ottobre 1847. La scultura esterna contemporanea, intitolata “La Libertà”, è un’opera in ferro dall’artista Antonio Scarfone. A questo punto ci addentriamo nell’analisi dei murales, un profondo e geniale gioco di rimandi e richiami letterari, musicali, naturali, come ci farà scoprire Alessandra. Dopo il murale dedicato alla vecchia fontana, un tempo luogo di incontri, appuntamenti e scambi sociali, ci soffermiamo su quello che omaggia i “poeti contadini”, un gruppo di rimatori e cantori, spesso provenienti da un contesto rurale, che sono ancora nella memoria di tanti (Michele Strati, Francesco Pulitanò, Michele Gigliotta, Carmela Barletta, Peppe Gallo) e che, oltre a recitare a memoria versi della Divina Commedia, tramandavano oralmente tradizioni e storie attraverso versi spontanei e popolari. I muri raccontano storie di artisti, scultori, letterati (molti sono dedicati a Saverio Strati, come quello di Tibi e Tascia, ma ci sono anche Dante Alighieri, per il settecentenario della sua morte, e Pierpaolo Pasolini) e di persone del luogo (“Cinema” in ricordo di Carlo Rossi e del suo cinema, piccola rivoluzione santagatese; la storia del pastore Brunello, un uomo del posto che mise fine ai soprusi di un signorotto locale pugnalandolo e che viene ricordato nel nome della contrada in cui si rifugiò). I “Cavalli dell’Apocalisse”, opera dell’artista siciliano Andrea Sposari, sono un omaggio all’artista Fabòn; il “Ragazzo illuminato dalla luce della storia” domina una parete su uno slargo e la luce rappresenta anche la ragione e la conoscenza che aprono la mente; “Linfa Vitale” realizzato durante il festival “Stratificazioni”; “Artemide”, dea della caccia e dei boschi, posta dietro alcuni versi dedicati alla luna in una canzone di De Andrè, dirimpetto a parole di Guccini che riecheggiano le doti dei “poeti contadini”.
Mentre camminiamo tra i vicoli giunge alle nostre orecchie una bellissima voce che canta le bellezze della zona ionica: è Romano Scarfone, che ci intrattiene allegramente con la sua chitarra e la graditissima sorpresa del nipotino Giovanni, che ci stupirà con la sua bravura canora e musicale (suona la chitarra anche lui). Siamo proprio dinnanzi alla casa di Saverio Strati e concludiamo qui la nostra visita: Alessandra ce ne racconta la vita, inclusa la genesi dell’opera “Tibi e Tascia”, che richiama un amore giovanile mai dimenticato, conclusosi a causa dell’allontanamento dello scrittore dal paese per motivi di studio (da poco si è scoperta l’esistenza di una lettera, ricevuta e imparata a memoria dalla “Tascia” reale e poi distrutta, in cui lo scrittore le chiedeva di aspettarlo). Dopo il conseguimento della licenza elementare Strati lavorò per un po’ come muratore, coltivando la sua passione per lo studio e la lettura di testi di cultura popolare e di grandi scrittori. Dopo la seconda guerra mondiale, riprese a studiare grazie all’aiuto finanziario di uno zio che viveva in America. Conseguì la licenza liceale classica e si iscrisse all’Università di Messina, prima alla facoltà di Medicina e poi a quella di Lettere. Iniziò a scrivere racconti, spronato da vari pareri favorevoli, tra i quali quello del critico letterario Giacomo Debenedetti che insegnava a Messina, e iniziò il suo primo romanzo, La Teda. Nel ’53 si trasferì a Firenze per preparare la tesi e continuando a dedicarsi alla scrittura. Nel 1958 sposò una ragazza svizzera e si trasferì in Svizzera dove scrisse i romanzi Mani Vuote e Il Nodo. Dal soggiorno in Svizzera nacque il romanzo Noi Lazzaroni. Dal 1964 si traferì a Scandicci, dove morì nel 2014.
L'Associazione Le Città Visibili

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736
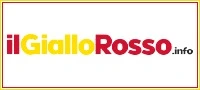








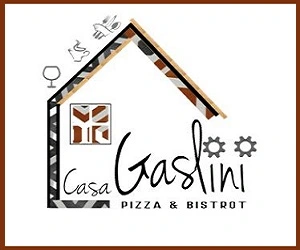
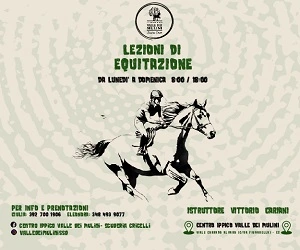
.webp)





