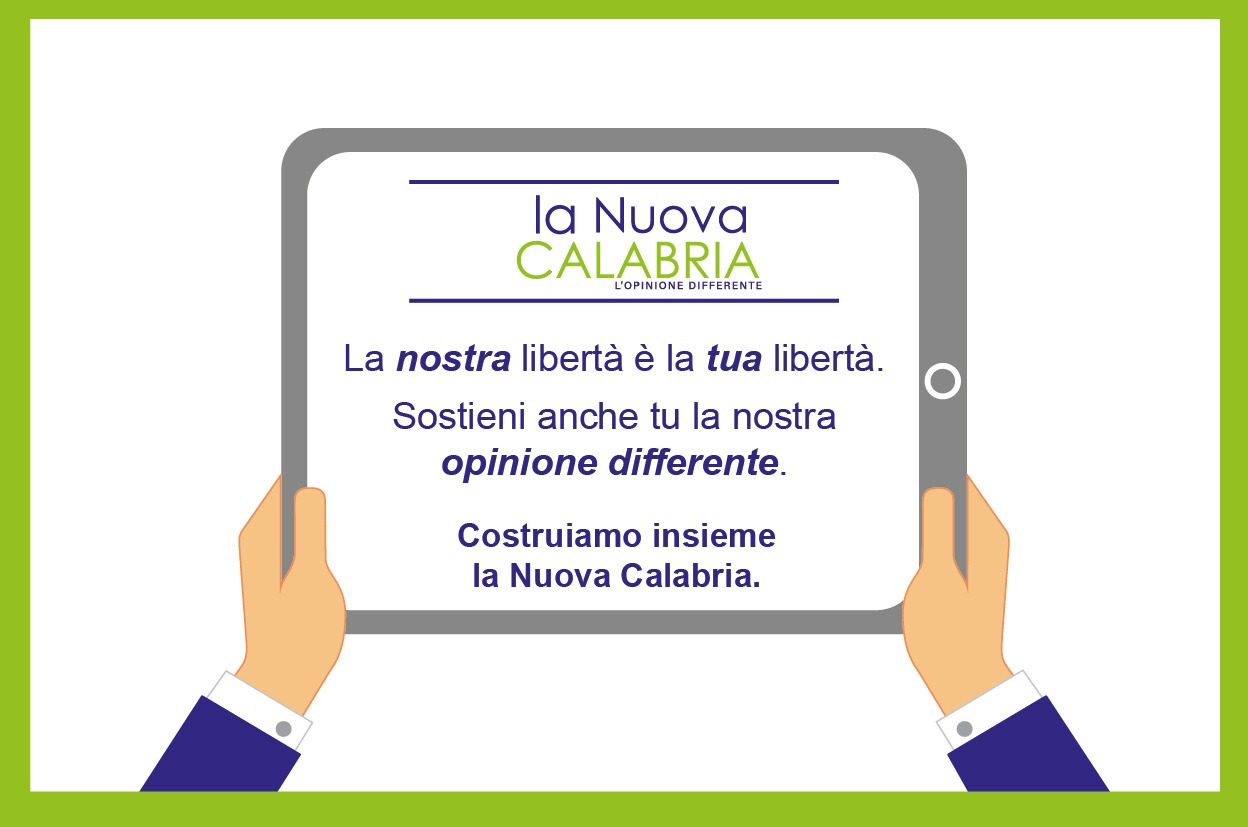Cimino: "Dalla celebrazione di un solo vincitore, il culto della potenza e del super-io che lo impersona"




13 ottobre 2025 21:07
di FRANCO CIMINO
Oggi, da stamattina presto e fino all’ora in cui scrivo — quella in cui, in Egitto, non è stato ancora firmato a più mani il cosiddetto accordo americano-israeliano per la pace — sul medesimo teatro, quello mediorientale, e in particolare lungo la linea di confine che separa Israele dalla Striscia di Gaza, sono andate in scena due opere: il dramma e la commedia.
Entrambe scritte e dirette dagli stessi autori: cultori dell’odio e della potenza, costruttori di guerre per ricostruire ricchezze sulla guerra stessa.
Le due rappresentazioni sono legate da un unico motivo: la speranza.
Ambedue si muovono secondo lo schema proprio del teatro: il dolore e il suo superamento, la lotta, il combattimento, e infine la quiete che segue. L’odio e l’amore, la sconfitta e la vittoria, i vinti e i vincitori. La fatica del vivere, la fame e l’opulenza.
Due opere rappresentate sotto un’unica regia — sempre la stessa — sullo stesso palcoscenico, sul quale non è ancora calato il sipario ma da cui già si levano, dalla grande platea e dai loggioni, le urla festose e le acclamazioni dei tifosi dell’unica commedia possibile: quella del vincitore.
Commuovono le immagini delle decine di migliaia di palestinesi lungo la strada che costeggia quel mare magnifico e li riconduce verso le città dalle quali sono stati cacciati o dalle quali sono dovuti fuggire per non morire massacrati come i loro parenti, amici e conoscenti.
Tornano nella speranza di ritrovare qualcosa delle loro case distrutte, o almeno un frammento delle loro vite sepolte sotto le macerie. Cercano, in quel che resta della loro forza fisica, la possibilità di ricostruire con le proprie mani le loro città, di ripulire dal fuoco, dalle ceneri, dalle schegge quelle terre che essi stessi avevano coltivato.
Commuove, poco più distante da quella lunga strada, l’immagine doppia delle vite degli ostaggi israeliani: i pochi superstiti liberati dalle prigioni sotterranee di Hamas, dove erano stati rinchiusi dal tragico e orribile 7 ottobre di due anni fa, e i corpi dei loro compagni morti di stenti o uccisi durante la prigionia.
Dall’altra parte del confine — più volte violato — un’altra scena: quella della liberazione di un numero molto maggiore di palestinesi, i “ soldati”. Di Hamas prigionieri nelle carceri di Tel Aviv, restituiti alle loro comunità.
Qui si consuma il dramma, tra fatiche, lutti, dolori, rabbia, ansia, gioia e speranza.
La commedia, invece, è andata in scena a Tel Aviv, sul palcoscenico della Knesset, sede del Parlamento, dove il vincitore di tutte le battaglie — come celebrato da tutti i corifei — è stato incoronato come egli stesso forse non immaginava.
Il Presidente degli Stati Uniti d’America è stato accolto con gli onori riservati agli imperatori che la storia ha reso grandi, e richiamato in tal senso anche dalle parole del portavoce del Parlamento, del capo del governo israeliano e perfino del leader dell’opposizione.
È stata una grande festa che ha incoronato il nuovo imperatore del pianeta.
E lui, preso la parola in mondovisione, con la sua riconosciuta teatralità accattivante, è andato oltre la stessa celebrazione della propria grandezza, oltre la stessa incoronazione.
Nel suo discorso di settanta minuti, il Presidente americano ha pronunciato un solo pronome: “Io”.
“Io ho chiuso, in otto mesi, otto guerre. Io sono l’artefice della fine della più drammatica. Io ho liberato gli ostaggi. Io ho costruito un’America più grande, più ricca, più potente, più temuta, più rispettata che mai. Io ho sostenuto Israele, militarmente ed economicamente, portandola a una vittoria schiacciante nella quale pochi credevano, persino in Israele. Io ho avviato un disegno che renderà ricchi o più ricchi tutti gli amici dell’America, attraverso gli investimenti nella ricostruzione di Gaza e delle aree distrutte dalle guerre. Io prenderò con me questi nuovi protagonisti del nuovo assetto planetario: chi resterà fuori diventerà povero, debole, ed esposto alla violenta reazione americana se solo tenterà di opporsi. Io sono il padrone del mondo.”
Io — il mio io piccolo, minuscolo — oggi mi sono sentito incredibilmente vecchio.
La memoria che mi batte nel petto non ricorda di aver mai udito parole così inquietanti, un discorso tanto arrogante, una dichiarazione di volontà di imperio così manifesta come quella pronunciata oggi dal Presidente americano.
Ho dovuto riflettere a lungo, prima di scrivere, come faccio ogni giorno da tre anni, sui fatti di guerra e sulla disperante speranza della pace.
Ma i commenti ascoltati per tutto il pomeriggio — chi con enfasi, chi con prudenza, ma tutti elogiativi del discorso e della persona del capo dell’amministrazione americana — mi hanno spinto a dire ancora una volta della mia preoccupazione per ciò che sta accadendo: il silenzio assordante delle opinioni pubbliche e delle intelligenze del mondo politico e culturale su un processo di risistemazione degli equilibri mondiali per nulla rassicurante.
Nel discorso di oggi, nell’Io elefantiaco, c’erano solo affari.
Solo economie che devono muoversi in direzione della ricchezza di chi è capace di produrla per sé e per il proprio Paese. L’umanità non c’era.
Nell’Io ipertrofico di quel discorso, la celebrazione dei vincitori; nessuna parola per i vinti.
L’esaltazione della forza fisica; nessuna parola per i deboli.
L’esaltazione della ricchezza come strumento di potenza; nessuna parola per la povertà e per i poveri generati da quella cultura della ricchezza.
La riaffermazione del culto della potenza militare e del valore assoluto delle armi nella soluzione dei conflitti.
E in tutto questo, nessuna parola per le vite umane. Nessuna per i morti.
Nessuna per chi ha fame e sete, per chi è nudo, per chi è stato cacciato dalle proprie terre e derubato delle proprie ricchezze.
In quell’Io che non finisce mai c’è persino un’idea religiosa: la convinzione della propria natura divina e del ruolo salvifico che si attribuisce nel mondo.
Un Io che non concepisce il Noi, e dunque non riconosce né la libertà autentica né la democrazia vera, quella che libera gli altri liberando prima se stessa dal culto della potenza.
In quell’Io odierno, proclamato nel Parlamento israeliano, c’è un’idea particolare della pace: quella quiete che arriva solo quando il potente non trova più nulla da distruggere, né vita da uccidere.
Una pace imposta dal vincitore, senza o contro gli sconfitti.
In quell’Io, infine, c’è l’avvertimento ai Paesi non allineati: abbiate paura.
E c’è l’esaltazione dello Stato di Israele come rappresentante di tutti gli interessi di questa nuova pace mediorientale. E la promessa che Israele esisterà sempre, ma nessuna parola sulla nascita dello Stato palestinese.
Neppure un richiamo al patto di Oslo del 1993, quello di Arafat e Rabin, che prevedeva due popoli e due Stati liberi e indipendenti. Solo un riferimento retorico al Patto di Abramo.
Fermo restando che tutto ciò che fa cessare una guerra e gli ammazzamenti è cosa straordinariamente utile e bella — anche se sospesa su un filo sottilissimo — io continuo a restare vigile e criticamente attento a tutte le dinamiche che si intrecciano sulla paura, sottile ma profonda, che il nuovo mondo che si vorrà far nascere non sia più bello di quello che oggi vorremmo lasciare.
Segui La Nuova Calabria sui social

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019
Direttore responsabile: Enzo Cosentino
Direttore editoriale: Stefania Papaleo
Redazione centrale: Vico dell'Onda 5
88100 Catanzaro (CZ)
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Sirinfo Srl
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 3508267797
© La Nuova Calabria 2019
Versione App v.1.0.0
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy . Chiudendo questo banner, o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.