Conidi Ridola: "Intercettazioni e cellulari illeciti in carcere, prova valida o trappola per la giustizia?"




25 agosto 2025 16:02
di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA
La questione delle intercettazioni relative a conversazioni tra detenuti e soggetti esterni, effettuate tramite cellulari illecitamente introdotti in carcere, è di stringente attualità e di grande complessità giuridica. Ci si chiede: può la Procura avvalersi di tali intercettazioni come mezzo di prova, pur se originano da un illecito carcerario? O si rischia di incrinare i principi fondamentali del processo penale?
Il quadro normativo prevede delle regole ben precise.
Il codice di procedura penale disciplina le intercettazioni agli artt. 266 e seguenti c.p.p..
L’art. 266 c.p.p. individua i reati per i quali le intercettazioni sono consentite.
L’art. 267 c.p.p. richiede un decreto motivato del giudice, su richiesta del PM, fondato su gravi indizi di reato e indispensabilità della misura.
L’art. 271 c.p.p. sancisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza autorizzazione del giudice.
L’art. 191 c.p.p. prevede l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge.
Il dato normativo non esclude la legittimità della prova per il solo fatto che il detenuto utilizzi uno strumento vietato (il cellulare). Il problema riguarda piuttosto la correttezza dell’attività investigativa e l’affidabilità del materiale probatorio.
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato casi analoghi: Cass., Sez. Un., n. 36747/2003, Torcasio: ha distinto l’inutilizzabilità “patologica” (intercettazioni senza decreto o fuori dai casi previsti) dalle ipotesi in cui la prova sia solo “anomala” ma comunque legittima.
Cass., Sez. VI, n. 18908/2011: ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche effettuate tramite cellulari introdotti abusivamente in carcere, se autorizzate correttamente.
Cass., Sez. V, n. 42545/2024: ha ribadito che le intercettazioni inserite nel fascicolo dibattimentale in violazione dell’art. 270 c.p.p. sono inutilizzabili, anche se materialmente presenti.
Cass., Sez. II, n. 4189/2025: ha qualificato come ricettazione (art. 648 c.p.) la condotta del detenuto che riceve un cellulare introdotto abusivamente, evidenziando la gravità del fenomeno e la sua duplice natura: strumento di reato e mezzo di comunicazione.
La giurisprudenza, dunque, si muove in senso pragmatico: la illiceità del possesso del telefono non invalida automaticamente la captazione, purché l’attività investigativa sia stata condotta nei limiti di legge.
C’è, però, un dato altamente rischioso e non valutato:
Il rischio della “furbizia del detenuto”: dato, altresì, non dimostrabile.
Tale aspetto rischia di essere sottovalutato: il detenuto non è un soggetto passivo.
Può utilizzare consapevolmente il cellulare come strumento di depistaggio, immaginando che la sua utenza sia monitorata, o quella del destinatario della sua comunicazione.
Può costruire così discorsi fittizi per indurre in errore la Procura.
Può indirizzare gli inquirenti verso piste fuorvianti.
Può creare un apparente “flusso probatorio” che, in realtà ,è solo un artificio difensivo.
Così, il telefono illecito non è più soltanto un’occasione di prova, ma un’arma nelle mani del detenuto per inquinare le indagini. Il risultato? Un vero e proprio gap probatorio che mina le garanzie del processo penale: la Procura rischia di portare in aula intercettazioni manipolate, apparentemente genuine ma in realtà preordinate a deviare l’accertamento dei fatti per i quali quelle intercettazioni erano state disposte o introitare dati assolutamente contrari all’accertamento di verità o responsabilità penali, anche in capo a terzi ignari.
La Tecnologia così, può facilmente diventare un’arma a doppio taglio.
La tecnologia,infatti, se non governata, rischia di trasformarsi da alleato a nemico del sistema giudiziario.
È sempre più frequente imbattersi in detenuti che, tramite cellulari clandestini, partecipano a social come TikTok, vanno in diretta online, chattano in gruppo, rompendo simbolicamente le mura del carcere ed espandendo la loro capacità di comunicazione ben oltre i limiti imposti dalla misura detentiva.
Questa possibilità non è neutra: consente al detenuto di ricevere informazioni dall’esterno che non dovrebbe conoscere; gli permette di coordinare comunicazioni con persone sottoposte a intercettazione, minando così la genuinità della prova; può dare vita a reti comunicative parallele, in grado di influenzare l’attività investigativa dall’interno del carcere.
Il rischio per la Procura è concreto: anziché rafforzare le indagini, queste captazioni possono trasformarsi in un boomerang processuale, offrendo alla difesa l’occasione per dimostrarne la pretestuosità o l’inaffidabilità.
Il possesso illecito di cellulari in carcere è oggi molto più che un problema di ordine interno: è una vera e propria sfida al sistema probatorio.
Se è vero che le intercettazioni, debitamente autorizzate, restano formalmente utilizzabili, è altrettanto vero che la loro genuinità e attendibilità devono essere valutate con estrema cautela. La tecnologia, infatti, non è soltanto uno strumento nelle mani dello Stato, ma può diventare una risorsa tattica per il detenuto o di chi di lui possa servirsi dall’esterno.
In questo contesto, la tecnologia si rivela un’arma a doppio taglio: da un lato offre alla Procura mezzi straordinari di ricerca della prova, dall’altro rischia di creare crepe profonde nel sistema investigativo, aprendo la strada a depistaggi, manipolazioni e false piste.
La vera sfida del diritto processuale penale contemporaneo sarà allora duplice: non farsi ingannare dall’apparente immediatezza della tecnologia e al contempo rafforzare le garanzie processuali, affinché l’acquisizione della prova resti fedele alla sua missione originaria: la ricerca della verità, non la costruzione di illusioni probatorie o di artifizi destinati a falsare la verità oggettiva dei fatti.
*avvocato

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736










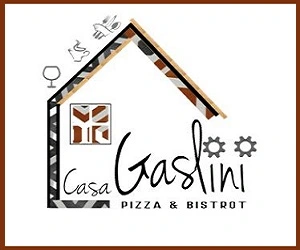



.webp)


