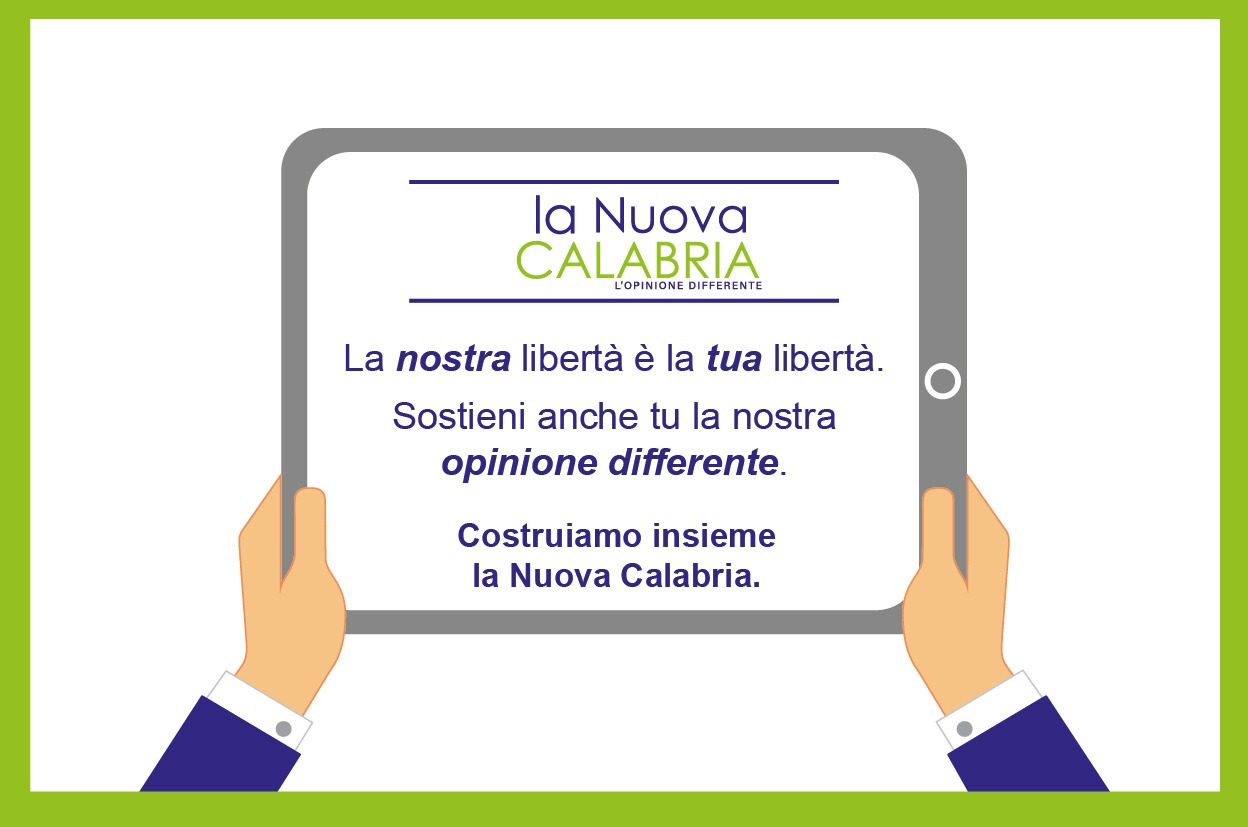Conidi Ridola: "Meloni, basta giochi, tuteli i collaboratori o chiuda l’istituto"




07 ottobre 2025 12:22
di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
Quello che sta accadendo oggi ai collaboratori di giustizia rappresenta una frattura profonda dello Stato di diritto. Persone che hanno scelto di rompere con il loro passato criminale e di mettere a rischio la propria vita e quella delle loro famiglie vengono, una volta usciti dal programma di protezione, schiacciate dai debiti erariali, spesso accumulati prima della collaborazione, impedendo in concreto qualsiasi possibilità di reinserimento sociale ed economico. La legge 15 marzo 1991 n. 82, integrata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45 e dalle successive modifiche, prevedeva la capitalizzazione ai sensi degli articoli 16-ter e 16-quater come forma di fuoriuscita dal sistema di protezione, un sostegno economico per costruire un futuro altrove in sicurezza e dignità. Analogamente, il Codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) continua a prevedere tutela, protezione e capitalizzazione per i collaboratori di giustizia, sancendo la possibilità concreta di sostegno economico finalizzato al reinserimento.
Tuttavia, nella pratica amministrativa, le somme previste dalla legge 82/1991 e dal Codice antimafia, strumenti fondamentali per garantire autonomia, sicurezza e prospettive di vita ai collaboratori, sono state trattenute, sospese o sottoposte a controlli preventivi in ragione di debiti fiscali o vincoli amministrativi. Ciò ha neutralizzato la funzione originaria di protezione economica e reinserimento sociale. Così, ciò che era concepito come un diritto speciale si è trasformato in un percorso subordinato a logiche contabili generali, con ricadute pesanti sulla vita reale dei collaboratori di giustizia.
Tale meccanismo è stato recepito in atti applicativi, inclusa la delibera di massima della Commissione centrale ex articolo 10 della legge n. 82 del 1991 oggetto della mia impugnativa. I collaboratori non sono realmente liberi di cercare lavoro come qualunque cittadino, portano addosso stigmi di reati passati, anni di carcere, identità schermate, isolamento sociale e impossibilità oggettiva di costruire relazioni lavorative. Oggi chi sceglie di collaborare lo fa sapendo che non avrà futuro. In passato ci si pentiva anche per ricostruirsi una vita, oggi è una condanna a una sopravvivenza senza prospettive. I numeri lo confermano: secondo la Relazione al Parlamento del Ministero dell’Interno, al 31 dicembre 2023 risultavano 793 collaboratori di giustizia, in calo rispetto ai 891 dell’anno precedente, e nonostante non siano disponibili dati ufficiali aggiornati al 2025, è plausibile che questa tendenza al decremento continui. La diminuzione dei collaboratori significa che gli intenti dello Stato, nel disincentivare chi collabora, coincidono paradossalmente con quelli della mafia, che da sempre ha interesse a isolare chi decide di rompere il vincolo criminale.
Oggi la stessa destra che, con Berlusconi, introdusse e rafforzò la legge sui pentiti, sembra voler rottamare quell’istituto attraverso prassi amministrative e interpretazioni che neutralizzano la tutela economica prevista dalla legge. È la stessa porta di ingresso – chi collabora – e la stessa porta di uscita – chiude il futuro ai collaboratori, trasformando protezione e reinserimento in strumenti di bilancio e controllo. Il messaggio è chiaro: lo Stato può usare il collaboratore quando serve e abbandonarlo quando conviene, cancellando l’intento originario della legislazione sui pentiti, che era quello di incentivare la collaborazione proteggendo chi rompeva con la criminalità.
Per questo il mio appello alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è netto: o si cambia la legge, ripristinandone la ratio originaria sancita dalla specialità delle norme introdotte con la legge n. 82 del 1991 e le sue modifiche, oppure si abbia il coraggio di ammettere che l’istituto della collaborazione con la giustizia è morto nella pratica. Non è possibile utilizzare il collaboratore quando serve, come fonte di prova nei processi penali, e poi abbandonarlo al momento del reinserimento. Le procure dovrebbero avere l’onestà di esplicitare subito questa realtà a chi si avvicina alla collaborazione, perché oggi lo Stato pretende testimonianza, rischio personale e rottura col passato senza garantire ciò che aveva promesso. È una sfida etica e costituzionale allo Stato italiano: se si usano i collaboratori per raggiungere le finalità della Costituzione, non si possono negare loro reinserimento, dignità sociale, diritto di voto e prospettiva di vita.
Da avvocato che da anni assiste collaboratori di giustizia, a fine ottobre discuterò dinanzi al TAR il ricorso contro la delibera di massima adottata dalla Commissione centrale ai sensi dell’art. 10 della legge n. 82 del 1991, che ha legittimato il diffondersi di questa informativa – un vero e proprio spauracchio – sulle erogazioni e capitalizzazioni destinate ai collaboratori. Se il TAR dovesse sostenere che solo in sede di liquidazione si potrà verificare se questa applicazione pregiudichi o meno la risocializzazione, prenderò atto che lo Stato ha fatto pigna contro i collaboratori. La questione giuridica è chiara: la lex specialis successiva prevale sulla lex generalis anteriore, e la disciplina speciale costruita per tutelare chi rischia la vita collaborando non può essere neutralizzata da prassi amministrative che reintroducono filtri generali.
Subordinare la capitalizzazione a verifiche fiscali preventive significa lanciare un messaggio chiaro: lo Stato protegge finché gli conviene, poi si ritrae. L’epoca della collaborazione non può essere ridotta a contabilità e vincoli amministrativi; o si ristabilisce la legge speciale, o si ammette la fine dell'istituto.
*Avvocato
Segui La Nuova Calabria sui social

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019
Direttore responsabile: Enzo Cosentino
Direttore editoriale: Stefania Papaleo
Redazione centrale: Vico dell'Onda 5
88100 Catanzaro (CZ)
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Sirinfo Srl
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 3508267797