Costituzione ed emergenza sanitaria: rischi e codardia



02 maggio 2020 21:07
L’emergenza sanitaria sul fronte giustizia ha posto, in questo ultimo periodo, con grande evidenza, all’attenzione di operatori e opinione pubblica due temi fondamentali: la necessità che la celebrazione del processo penale avvenga sempre senza intermediazioni tecnologiche, non da “remoto”, cioè, ma con la partecipazione fisica di tutti i protagonisti del processo (ovviamente, con le eccezioni già previste quanto alla partecipazione di talune categorie di imputati detenuti); il drammatico problema del sovraffollamento delle carceri, tema purtroppo ricorrente nel nostro Paese, ma che oggi ha assunto ulteriore connotazione di gravità ed urgenza a causa del diffondersi della malattia negli istituti di pena e, dunque, tra soggetti di fatto impossibilitati a difendersi dalla malattia stessa attraverso le misure precauzionali che tutti abbiamo imparato a conoscere e a praticare in questa difficile contingenza.
Si tratta di due questioni che costituiscono oggi un chiaro indicatore dello stato dei diritti e delle garanzie nella nostra società e dei pericoli di regressione che su tale fronte si corrono per il mai sopito – ed anzi sempre in agguato - spirito “reazionario” che sulle questioni di giustizia vorrebbe ciclicamente imporre opzioni autoritarie ed antistoriche.
Quanto alla prima questione, è indubbio che lo stato emergenziale sanitario abbia imposto – a causa delle giuste misure di distanziamento sociale – la necessità di prevedere, in particolare nei segmenti giudiziari corredati da stringenti e perentori termini di decadenza, forme telematiche di contatto tra giudice e parti. Ora, con la nuova normativa approvata proprio in questi giorni (L. 24.04.2020, n. 27, e D.L. 30.04.2020, n. 28), si è protratta – e mi riferisco qui in particolare al settore penale – fino al 31 luglio la previsione del possibile collegamento in udienza da remoto, escludendo tuttavia da tale eventualità alcune specifiche attività processuali (ad esempio, l’esame di testimoni e periti, ovvero la discussione conclusiva) ove non vi sia l’accordo delle parti per procedere con il collegamento telematico. Naturalmente, si tratta di misure straordinarie dettate dalla eccezionalità del periodo difficile e fortemente problematico che stiamo vivendo, modulate e rimodulate normativamente fin dal 17 marzo scorso (data del primo decreto legge che è intervenuto in materia di giustizia).
Eppure, è del tutto evidente di come si palesino spinte (manifeste o sottotraccia) che vorrebbero portare ad una stabilizzazione di tali previsioni normative, e cioè, in definitiva, all’utilizzo del c.d. processo da remoto anche in tempi di normalità e a pandemia superata. E così, se l’Associazione Nazionale Magistrati lamenta l’esclusione di talune attività processuali (quelle sopra indicate) dalla possibilità di un loro espletamento da remoto pur senza il consenso delle parti, una componente della magistratura associata (Area) addossa senza mezzi termini all’Avvocatura associata la “colpa” di aver salvaguardato lo svolgimento delle attività più delicate del processo in presenza fisica e, dunque, di non aver consentito un illimitato ricorso alla remotizzazione del processo stesso perlomeno in questa fase.
Del resto, singole voci di magistrati particolarmente presenti nel dibattito nazionale si erano già espresse chiaramente sul punto, sollecitando una definitiva adozione degli strumenti telematici nella celebrazione dei processi anche nel post pandemia (ad esempio, i dottori Davigo e Castelli, mentre del dott. Gratteri si conosce il pensiero su tali temi anche in tempi pregressi alla attuale situazione emergenziale). Ed allora, è facile prevedere che passata la fase acuta dell’emergenza sanitaria (a breve, come tutti auspichiamo), la possibilità che il tema del processo da remoto non venga posto nel cassetto dei ricordi, sia pure amari, di questi mesi, è una possibilità quantomai concreta, e che la sollecitazione verso forme stabilmente disciplinate di connessione telematica nella celebrazione dei processi sarà una richiesta che non verrà accantonata con il passare della emergenza sanitaria stessa. Ebbene, come ormai da più parti si è sottolineato, il rifiuto netto e definitivo di ogni ipotesi di smaterializzazione del processo penale dovrà essere ribadito e riaffermato in ogni sede ed in maniera assolutamente irremovibile. Si dovrà ricordare ai fautori, per così dire, della banda larga processuale, che nel giudizio penale si tratta di beni, diritti e valori che hanno il loro fondamento e la loro tutela massima nella Carta costituzionale - primo fra tutti la libertà personale – e che non è nemmeno lontanamente concepibile che un accertamento che ha nella oralità e nella immediatezza i suoi cardini fondamentali venga ad essere ridotto ad una mera operazione tecnologica (con tutti i limiti già noti e che ben si possono intuire nella loro devastante incidenza se portati su scala più ampia) buona soltanto a dare una tranquillizzante proiezione esterna – invero del tutto formale e “finta” – di quel principio costituzionale irrinunciabile che è dettato dall’art. 111 della Carta fondamentale e che vuole il pieno e garantito contraddittorio tra le parti come metodo e sistema insostituibile nell’accertamento della responsabilità penale.
Se declineremo verso forme “artificiali” di contatto tra le parti del processo e tra le stesse e il giudice chiamato a decidere, imboccheremo senza alcun dubbio la strada senza ritorno di un abbassamento progressivo e inesorabile del livello delle garanzie (già oggi è ben chiara la difficoltà di gestione del rapporto difensore – imputato detenuto nei collegamenti in videoconferenza), con una prospettiva di graduale oscuramento dell’incisività concreta del diritto di difesa - costituzionalmente garantito - e con una pericolosa deriva autoritaria dell’accertamento giudiziario. E’ una prospettiva che deve essere rifiutata dall’intera società civile e democratica e non soltanto da una parte di essa (con l’Avvocatura associata in testa), giacchè con essa entrano in gioco dinamiche essenziali ed irrinunciabili della nostra vita associata, che si ricollegano alla tutela effettiva dei diritti primari dei singoli individui nel delicatissimo ed articolato rapporto tra essi e l’autorità dello Stato.
Sotto altro e non meno rilevante profilo, la questione del sovraffollamento delle carceri nel nostro Paese è riesplosa in modo drammatico in coincidenza con la sopravvenuta emergenza sanitaria. Siamo ritornati in pochi anni ad un livello di intollerabile sovraffollamento negli istituti penitenziari: secondo i dati del Ministero della Giustizia, aggiornati al 31 marzo scorso, la popolazione carceraria è di 57.846 unità a fronte di una capienza regolamentare di 50.754 posti. Dunque, un delta negativo di oltre 7.000 unità che, benchè in decrescita rispetto all’ultimo dato disponibile risalente alla fine di febbraio, indica una chiara situazione di costante e patologico allontanamento dalla normalità. Nel frattempo, è cresciuto il numero dei contagiati per coronavirus tra i detenuti (159), ed è proprio di ieri la notizia del 7° morto a causa del virus tra le persone ristrette in carcere (un detenuto presso il carcere di San Vittore a Milano). Del tutto insufficiente l’intervento governativo per decongestionare la realtà carceraria in questo momento di grave difficoltà - attraverso le blande e sostanzialmente inefficaci misure previste dal c.d. decreto cura Italia - nulla compare alle viste per porre mano strutturalmente ad un problema che si è voluto, da molti anni a questa parte, accantonare con incredibile e supponente approssimazione.
Ed anzi sono montate le polemiche strumentali e demagogiche rivolte all’autonomia valutativa della magistratura di sorveglianza (il riferimento è al recente caso Zagaria e ad altri simili), che hanno determinato, con gli ultimi interventi legislativi, una sostanziale delega agli Uffici del Pubblico Ministero in ordine alla concedibilità dei benefici penitenziari in taluni casi di possibile incompatibilità con il regime carcerario a causa di conclamate, gravi condizioni di salute del detenuto. E se l’intollerabile ed incivile situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari del nostro Paese e la conseguente necessità – vieppiù in presenza della violenta aggressione del virus - di porvi efficacemente rimedio è stata oggetto, anche recentemente, di numerose ed autorevoli prese di posizione (dall’Unione delle Camere Penali a importanti componenti della magistratura associata, come Magistratura Democratica, dai presidenti dei Tribunali di Sorveglianza lombardi a singole e rappresentative voci della comunità dei giuristi e del mondo culturale e politico italiano, ultime delle quali quelle dell’ex ministro della Giustizia, Giovanni Maria Flick, e dell’ex presidente della Corte Costituzionale, Valerio Onida), il tema carcere rimane, specie nello scenario politico attuale, una sorta di tabù e di zona franca quanto a possibili interventi migliorativi in ordine alle condizioni di vivibilità all’interno degli istituti penitenziari.
Eppure, l’emergenza causata dalla pandemia ha indotto numerosi governi nel mondo a varare misure deflattive della popolazione carceraria, onde prevenire il rischio di una esplosione incontrollabile della epidemia nelle case di reclusione, e finanche la Turchia – Paese, com’è noto, caratterizzato da una democrazia soltanto di facciata – ha adottato, ad inizio dell’emergenza sanitaria, un ampio provvedimento di clemenza che ha alleggerito in maniera drastica la popolazione carceraria nazionale. In Italia, invece, nonostante il sempre preoccupante andamento dei numeri sul sovraffollamento carcerario, si ha la netta sensazione – e ormai da molto tempo a questa parte – che pronunciare le parole amnistia e indulto costituisca né più né meno che un’eresia, una sorta di astratta evocazione fuori dal tempo e dallo spazio. Ma si dovrebbe, invece, sempre rammentare che si tratta di istituti previsti dalla nostra Costituzione e che la loro attivazione - con particolare riferimento all’indulto – rappresenterebbe null’altro - in ispecie in taluni periodi storici - che una prova di consapevolezza e di razionale apprezzamento della realtà delle cose in una democrazia liberale come la nostra fondata su consolidati principi di civiltà sociale e giuridica. Vien da pensare, però, che agli atti utili e razionali, non disgiunti da un mai improprio spirito umanitario, molti preferiscano la codardia degli occhi chiusi, del silenzio e del facile consenso.
Aldo Casalinuovo

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736







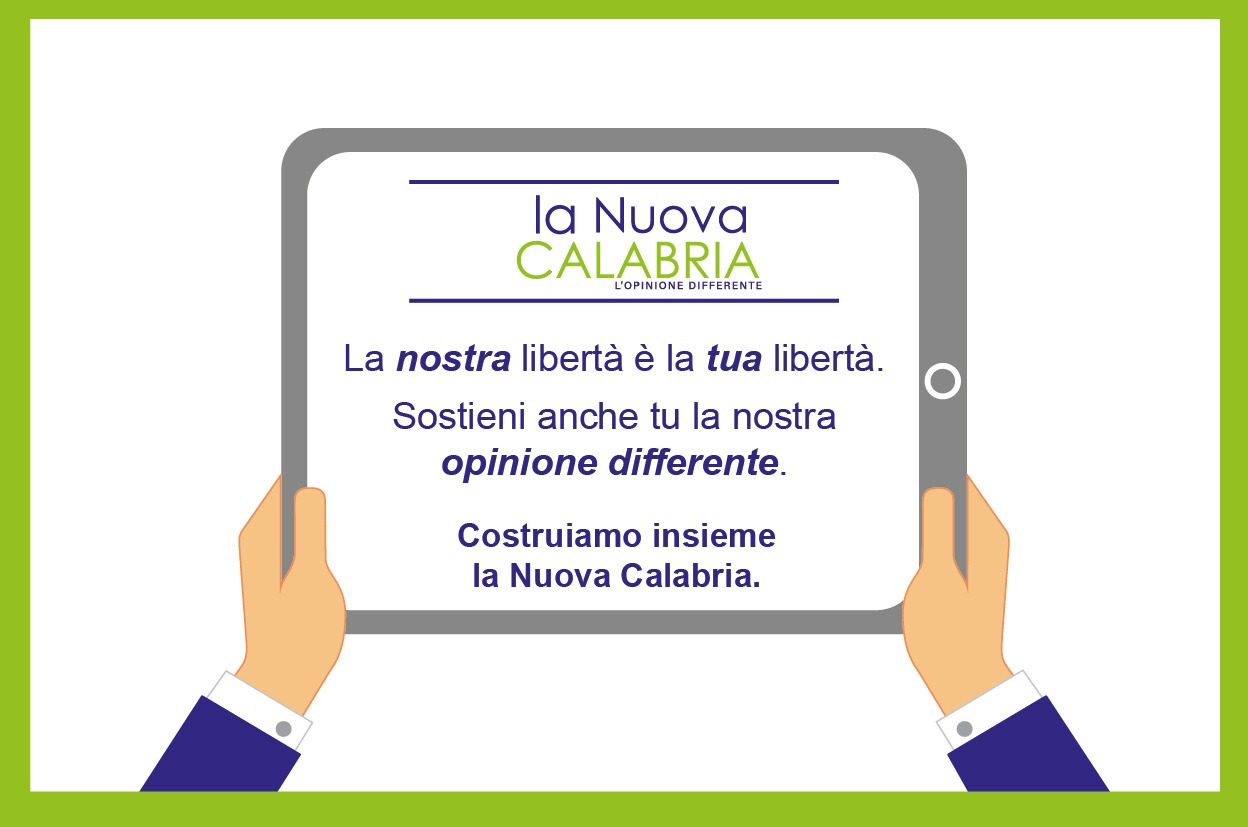








.webp)