Il mestiere di storico "raccontato" dallo storico Vanni Clodomiro




22 maggio 2021 21:14
di VANNI CLODOMIRO
Chi come me, con molta umiltà, fa il mestiere di storico sa bene che si tratta di un lavoro molto più difficile di quanto generalmente il grande pubblico non creda: non si tratta di semplici ricerche d’archivio e basta. Ma, per non perderci in affermazioni di carattere generale, e per evitare inutili prolissità, vogliamo subito entrare nel cuore della questione di ciò che si intende per storia e di ciò che si intende per singolo avvenimento: in particolare, il rapporto tra avvenimento e mutamento della storia. Uno dei problemi fondamentali è questo: un avvenimento crea un cambiamento nel corso della storia? Anzitutto, premettiamo che non bisogna lasciarsi, per così dire, ipnotizzare dall’avvenimento inteso come creatore del cambiamento. Magari, lo si può considerare come rivelatore, nel senso cioè che l’avvenimento può essere ritenuto anche un acceleratore: è infatti certo che un qualunque evento non sia in ogni caso una creazione dal nulla. In quanto rivelatore-acceleratore, crediamo perciò che la sua azione sia quella di concatenare un certo numero di evoluzioni, di cambiamenti che prima erano magari isolati l’uno dall’altro: stabiliamo quindi che l’avvenimento ha il compito di legare un certo numero di cambiamenti già in atto. Facciamo qualche esempio: la Rivoluzione francese, la guerra del 14-18, l’avvento di Giovanni XXIII al trono papale conservano in ogni caso un carattere di causalità.
Inoltre, dobbiamo aggiungere che il concetto di avvenimento è strettamente legato ad una mentalità evenemenziale (anche se questo può sembrare un circolo vizioso): una delle acquisizioni più significative della storia recente è proprio l’attenzione prestata alle mentalità. Questo non contrasta l’interpretazione evenemenziale della storia di Marc Bloch e Lucien Febvre, fondatori della famosa Rivista «Annales»; ma crediamo piuttosto che possa ritenersi un completamento: vogliamo con ciò dire che l’avvenimento è ovviamente fondamentale, ma non è tutto; la mentalità con cui lo stesso viene interpretato è altrettanto importante. Ad esempio, vedere nella guerra o nella pandemia un fattore di cambiamento può generare a sua volta un cambiamento: questa è una delle acquisizioni della storia delle mentalità. D’altra parte, questa storia delle mentalità può diventare anche pericolosa, nel senso che si potrebbe correre il rischio di sovrapporre la mentalità ai fatti e alle strutture, generando così un’ambiguità interpretativa, proprio perché la mentalità è un elemento che ha un notevole peso in rapporto alla generale problematica di un avvenimento.
A questo punto, si pone un’altra questione: la durata del cambiamento. Fernand Braudel pose l’accento proprio sulla lunga durata del cambiamento. Ovviamemte, non vogliamo qui ripetere le lezioni di Braudel, perché lo faremmo infinitamente peggio, ma prendiamo spunto da esse, per parlare della durata: essa dipende, secondo noi, dalla struttura di una società, vale a dire dal sistema sociale. A questo punto, qualcuno potrebbe paventare il fatto che la lunga durata possa coincidere quasi con l’immobilismo della storia: in realtà, invece, nessuno storico ha mai pensato che possa esistere una storia immobile, in quanto, nella durata degli eventi, entrano in ballo anche i ritmi strutturali e sociologici, capaci di mutare nel tempo, per quella che possiamo definire la creatività e la fantasia dell’uomo. E questo garantisce lo svolgimento della storia, al di là della durata. Anzi, la storia guarda anzitutto al tempo e, per dirla tutta, anche allo spazio: è infatti evidente che ogni realtà è senz’altro realtà spazio-temporale. Questo vuol dire che diventa indispensabile anche una collaborazione tra storia e geografia, pur rimanendo esse due discipline distinte. La geostoria, come diceva Braudel, è qualcosa di fondamentale, ma restiamo comunque convinti che le due discipline non possono comunque andare oltre la collaborazione.
Per tornare alla lunga durata e al tempo in cui si svolge, non si può trascurare la questione dell’interpretazione della storia. A questo proposito, vogliamo prendere ad esempio la famosa tesi sostenuta da Eric John Ernest Hobsbawm del cosiddetto secolo breve, che andrebbe dalla prima guerra mondiale al crollo dell’Unione Sovietica. Secondo noi invece la durata del secolo scorso è tutt’altro che breve: intendiamo cioè dire che il 1900 deve essere, al contrario, considerato un secolo lungo, perché, di fatto, i segni premonitori di ciò che sarebbe accaduto in quel secolo si ebbero già nell’ultimo ventennio dell’800; non solo, ma il vero mutamento epocale della storia contemporanea si concretizza con l’abbattimento delle torri gemelle. Dunque, lunga durata, e molti eventi importanti, a dimostrazione del fatto che la storia tutto è tranne che immobile.
Quindi, tornando al problema interpretativo della storia, si pone la questione della verità storica: si può dire che probabilmente, per il passato, qualche criterio di generale verità dei fatti si può stabilire. Al contrario, per il presente, e specie per il futuro, è molto più difficile distinguere tra una verità che si dice oggettiva e i propri desideri, le proprie ideologie ecc. In quel caso, bisogna fare attenzione a non cadere nell’ambito della politica, che non è propriamente compito dello storico. Fare storia del presente comporta il rischio di sostituire la politica alla storia, confondendo così l’una e l’altra in una equivoca mescolanza che non fa bene né alla storia, né alla politica. Compito della storia è quello di consegnare ad un pubblico, possibilmente il più vasto possibile, la conoscenze acquisite con lo studio del passato. In questo modo, si offre un quadro solido, sul quale agire nel presente. Ma, ripetiamo, questo è il compito della politica. Lo storico ha piuttosto una grande responsabilità: quella cioè di prendere in considerazione tutti elementi di cui viene a conoscenza, ovviamente trascurando quelli che non rivestono alcuna importanza. Ma anche questo è un compito delicatissimo, cioè la scelta dei documenti. Altrimenti, si potrebbe dire la storia è fatta non dagli avvenimenti, ma proprio dagli storici che riportano i fatti. E si badi, questa non è che sia proprio un’eresia: ci sono storici come Jacques Le Goff, che hanno insistito non poco su tale ipotesi.
Facciamo un banale esempio, per concludere il nostro discorso: tutti sanno del famoso passaggio di Giulio Cesare sul Rubicone. Ebbene, se nessuno avesse in un modo qualsiasi tramandato quel fatto, ebbene, quel fatto stesso, per noi, oggi semplicemente non sarebbe mai esistito, con la conseguenza di una conoscenza ancor meno completa della storia romana.

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736
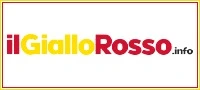













.webp)


