Silvestro Bressi: "Le origini di Catanzaro e la traslazione/fondazione della sua diocesi"



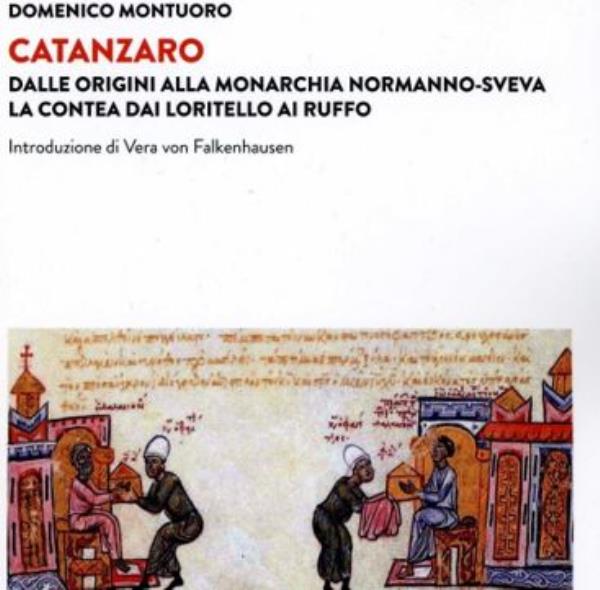
17 luglio 2021 14:40
di SILVESTRO BRESSI
Le origini di Catanzaro sono tra le più controvertite tra quelle delle città calabresi, soprattutto, perché a lungo sono mancate le fonti e le pubblicazioni che l’attestassero. La Chronica Trium Tabernarum, il cui codice più antico risale al XV secolo, anche se l’archetipo è sicuramente precedente, è stata pubblicata da Ferdinando Ughelli nel 1662 nel IX volume dell’Italia Sacra, in un’edizione poco corretta e piena di errori onomastici e toponomastici il che ha dato luogo al liquidatorio responso di fabulas elegantes che il manoscritto, ormai pubblicato in edizioni a stampa, si trascina tutt’ora.
Più fortuna tra i cultori di storia patria hanno avuto le opere di Luise Gariano, Vincenzo D’Amato e Domenico Marincola Pistoia. Infatti, fino alle edizioni (2006-2009) curate da Domenico Montuoro, autore del volume che si recensisce, mentre le opere a stampa di questi autori erano accessibili nelle biblioteche calabresi, della copia a stampa del codice manoscritto della Chronica - edizione Ughelli, ed Erich Caspar (1907) -, erano di difficilissima reperibilità, nelle biblioteche calabresi mancavano del tutto. Anche tra gli eruditi calabresi per secoli è invalsa la tradizione della “falsità” della Chronica e della mancata visita di Callisto II in Calabria. Fortunatamente negli ultimi decenni non sono mancati gli studi critici tesi a rivalutare questa importantissima fonte per ricostruire la storia medievale di Catanzaro e dell’area istmica, anche se, purtroppo, i cultori delle patrie memorie continuano a scrivere di “cronaca falsa”, pur conoscendola poco o niente, benché fornisca dei dati storici più documentati rispetto agli scrittori catanzaresi.
Preferiscono, naturalmente, celebrare anche loro il genetliaco della città (12 aprile 793 d.C.), quasi esattamente mille anni dopo quello di Roma (21 aprile 793 a.C.) dovuto a Romolo e Remo; mentre per quello catanzarese lo si attribuisce a Cataro o Cattaro e Zaro. Domenico Marincola Pistoia vissuto nell’Ottocento ha una migliore conoscenza degli eventi storici e si avvale degli autori meridionali precedenti.
La fondazione di una città, come gli studi storici e archeologici più recenti ormai largamente condividono, non è mai dovuta ad un ecista come nelle poleis magno-greche e nemmeno a eroi eponimi fratelli/gemelli, ma è un processo più ampio e più lungo nel tempo che sottende un utilizzo di un territorio che fornisce a chi vi si insedia i mezzi per permettere la sopravvivenza a un numero sempre maggiore di persone. È quanto avvenuto a Catanzaro, Troia, Melfi, Oppido, intorno, al 1042-1045 quando, come narra la Chronica Trium Tabernarum per la nostra città, e alcuni documenti superstiti per le altre, l’impero bizantino che cominciava a risentire di una crisi dovuta alla presenza nell’Italia meridionale dei ducati e gastaldati longobardi, e all’arrivo di nuovi guerrieri pronti a offrirsi al miglior offerente: i Normanni. Il basileus come extrema ratio fece rifondare le antiche città di Troia e Melfi in Puglia, e Oppido (l’antica Taurianum) in Calabria e riconobbe il chorion (villaggio) sul monte Catuanzarium o Triavonà, probabilmente, favorendone l’ampliamento tramite una diminuzione delle tassazioni.
Una ricostruzione dettagliata e, soprattutto, supportata dalle fonti e dagli studi più recenti sugli insediamenti abitativi altomedievali è quella presentata all’interno del volume dello studioso Domenico Montuoro dal titolo Catanzaro. Dalle origini alla monarchia normanno-sveva. La contea dai Loritello ai Ruffo, per i tipi della Rubbettino Editore.
Come dal titolo stesso, i contenuti del libro non si fermano soltanto alle origini e alle polemiche che ne sono scaturite, ma sempre con l’apporto costante dei documenti ne ricostruisce lo sviluppo in età normanna, dovuto soprattutto alla famiglia Altavilla/Loritello che con il conte Goffredo di Loritello riuscì ad ampliare il chorion divenuto kastron e successivamente civitas come testimonia la traslazione/fondazione del vescovato di Trischines/Trium Tabernarum a Catanzarij. All’interno del volume si trovano nuove informazioni sul primo conte Rodolfo (Rao, Raho) di Loritello e dalla moglie Berta, dei figli Goffredo e Raimondo, fino alla famosa contessa Clemenza. L’età sveva è scandita dai quasi sconosciuti conti Riccardo Fallucca. Anselmo de Justingen, Gherard von Solm e, soprattutto, Pietro de Calabria (Ruffo).
Il capitolo conclusivo è dedicato alla ricostruzione economica, sociale e religiosa della città ricostruita sulla base di 12 documenti privati in lingua greca e sulle notizie riportate da Padre Tromby nei suoi studi sull’eremo di S. Maria e sul monastero di S. Stefano del Bosco

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736






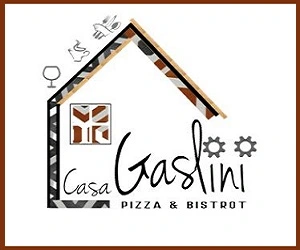


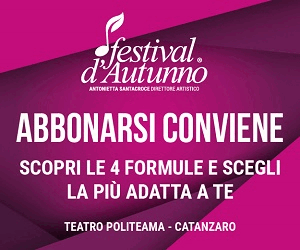

.webp)




