81 anni fa l'attentato in via Rasella a Roma, Ventura: “La Resistenza partigiana e i suoi protagonisti”




23 marzo 2025 08:56
di SABATINO NICOLA VENTURA
Mario Fiorentini, da giovane studente, aveva iniziato, già nel 1943, a svolgere attività clandestina in “Giustizia e Libertà” e nel Partito Comunista. È fra i promotori della formazione antifascista “Arditi del Popolo”. A settembre combatte contro i tedeschi a Porta san Paolo a Roma. Nell’autunno del ’43 è fra i costituenti dei Gap, comunisti (Gruppi Azione Patriottica). Assume il nome di battaglia di “Giovanni”. Partecipa a numerose azioni partigiane, fra le quali l’attacco a Via Rasella e al carcere di Regina Coeli. Dopo la liberazione di Roma, si lancia con il paracadute in Liguria per entrare nei gruppi partigiani del Nord. Ha combattuto in Emilia, Liguria, Lombardia e Piemonte. Fu ufficiale di collegamento col Servizio Segreto Americano. Più volte decorato, laureatosi, studiando in gran parte da autodidatta, fu docente di geometria superiore all’Università di Ferrara. Matematico di fama internazionale. Muore a Roma nel 2022 a 102 anni d’età).
Lucia Ottobrini, fidanzata di Mario Fiorentini, nata nel 1924, entranella resistenza Romana a 18 anni, nei Gap. Partecipa, assieme a Maria Muso e Carla Capponi, a numerose azioni partigiane (attacco alla caserma di Via Giulio Cesare; all’operazione per l’approntamento dei campi di lancio per gli alleati; all’attacco ai fascisti in Via Tomacelli; all’attacco ai nazisti in Via Rasella). Nel dopoguerra ha sposato Mario.
Perché questi nomi, subito all’inizio dello scritto? Perché l’attentato di Via Rasella nasce da loro due.
Fiorentini e Ottobrini, fidanzati, sono in clandestinità. Vivono a Roma in una cantina di un palazzo vicino al Colosseo, con altri resistenti. Nella cantina dove sono stati rifugiati dal portiere, che è un compagno, si vive malissimo, e un giorno dei primi di marzo decidono, per rifocillarsi e recuperare, di andare, rischiando la cattura, per un po' di giorni a casa di Mario Fiorentini, in Via Capo le Case, che è vuota; i genitori, ebrei, erano stati arrestati. Mario, nel primo pomeriggio, avverte il rumore di tanti passi cadenzati. Guarda da una finestra, e scorge una colonna di soldati tedeschi che marciano arrivando da piazza di Spagna. Valuta che sono in tanti, poco meno di duecento. Pensa alla possibilità di attaccarli. Promuove un incontro con altri ragazzi dei Gap per fare vedere la colonna, che ha constatato passa per quelle vie tutti i giorni e alla stessa ora. Si vedono lungo la strada il 19 marzo, ma la colonna non passa. Passa il 20. I componenti del gruppo di Mario Fiorentini, più quelli di un altro gruppo, e il loro Capo, un ragazzo di 21 anni, Rosario Bentivegna, (studente in medicina,appartenente a una famiglia impegnata, il bisnonno garibaldino)ritengono opportuno valutare concretamente la possibilità di attaccare quella colonna di tedeschi appartenenti alle SS, ma non possono decidere da soli, dovranno rispettare la gerarchia. (I Gap sono rigidamente strutturati, e pertanto obbligati dall’ordinamento interno). Alla testa dei Gap c’è il comunista Antonello Trombadori, che è, però, in galera. Lo sostituisce Carlo Salinari (Spartaco), un ragazzo di 25 anni, Assistente Universitario alla Sapienza; persona conosciuta quale grande studioso di letteratura italiana. Dopo la guerra sarà Preside della facoltà di Lettere alla Sapienza.
Bentivegna e Fiorentini si recano da Salinari per informarlo della colonna tedesca e dell’intenzione di attaccarla. Salinari è perplesso perché ritiene molto pericoloso il tentativo. Ma anche Salinari non ha il potere decisionale ultimo. Sopra di tutti c’è Giorgio Amendola, (Comunista. Nato a Roma il 1907 e morto a Roma il 1980. Figlio di Giovanni Amendola, liberale, ucciso dai fascisti. Giorgio è stato uno dei massimi dirigenti del PCI. È fra i fondatori del Comitato di Liberazione Nazionale. A Roma è il massimo dirigente dei Gap. Perseguitato politico durante il ventennio, fu confinato e in carcere. Dopo la liberazione è stato sottosegretario nel Governo Parri, e nel successivo con De Gasperi. Fu in prima fila nelle lotte per le conquiste operaie, per l’unità dell’Europa. Scrisse numerosi saggi. Fu il decisore dell’attentato di via Rasella, sempre rivendicato con orgoglio).,che contattato, dice di avere visto la colonna tedesca, perché percorre quelle strade per andare in Piazza di Spagna a incontrare Alcide De Gasperi, ricercato è rifugiato in territorio Vaticano, apalazzo di propaganda FIDE. Non può essere arrestato dai nazifascisti perché in territorio neutrale. Amendola condivide l’idea dell’attentato e lo propone alla Giunta Militare del Comitato di liberazione Nazionale, perché anche lui non può decidere da solo. La Giunta, in contatto con il Comando Alleato, che vogliono azioni contro i tedeschi a Roma, decide per l’attentato. Il Comandante della 5° Armata Americana, generale Mark Klark, che il cinque giugno 1944 libererà Roma dall’occupazione dei nazifascisti, riteneva molto importante queste azioni partigiane anche per dimostrare al nemico che i romani erano dalla loro parte: “…che alle spalle del nemico i partigiani non lo fanno mai stare tranquillo”.
L’azione di via Rasella è condotta dai comunisti dei Gap, con qualche disappunto degli altri partiti che avrebbero voluto essere coinvolti, ma a Roma sono i comunisti che hanno un minimo diforza militare. Pertini dirà di avere totalmente condiviso l’impresa, pur lamentando di non essere stato coinvolto. I giovani dei Gap sono allora incaricati a studiare e predisporre l’attacco. Per realizzarlo occorre avere il materiale per fabbricare la bomba e le armi necessarie, che glieli danno gli ufficiali dell’ex regioesercito agli ordini del governo Badoglio. (Questo gruppo di ufficiali era stato comandato, sino a pochi mesi prima, dal Colonnello Montezemolo, arrestato dai fascisti, morirà alle Fosse Ardeatine). L’attacco in via Rasella è realizzato da giovani già duramente provati dalla vita in clandestinità. La ragazza di Rosario Bentivegna dirà: la fame ci aveva ridotti magrissimi, pallidi, gli abiti ci cadevano addosso, le scarpe erano ridotti ai minimi termini, c’è chi portava gli zoccoli in pieno inverno. Sapevamo che se catturati saremmo stati torturati e uccisi. (chi è la ragazza di Rosario Bentivegna? Si chiama Carla Capponi, ha 25 anni, di buona famiglia: contessina. Sposerà Bentivegna dopo la guerra. Sarà deputata comunista). Franco Calamandrei, figlio di Piero, ricorda con ammirazione le ragazze dei Gap: furono giovanedonne che hanno preteso e conquistato il diritto di essere nell’azioni alla pari con i ragazzi. Sono state in prima fila anche in quelle più pericolose, come via Rasella. A Lucia Ottobrini fu conferita la medaglia d’argento.
I ragazzi studiarono ogni movimento della colonna tedesca, che, bisogna ricordare, è formata da SS della polizia militare,impegnati nei rastrellamenti per la cattura dei partigiani e dei sospetti.
Decidono di fare l’attentato in una delle strade del percorso della colonna, in via Rasella, strada un po' stretta e in salita. Lo faranno con una carica di tritolo nascosta in un carrettino per la raccolta dell’immondizia, e anche con il lancio di bombe e colpi di pistola. Sono in diciassette compreso quattro donne. È sicuramente un’azione ardita. Carla Capponi andrà a prendere l’esplosivo che con cautela, poco per volta, sono 18 Kg., da via Urbana lo porterà in via Marco Aurelio (alla cantina che è il rifugio del gruppo). Giulio Cortini che studia fisica, e che sarà un importante fisico nucleare, insieme alla moglie fabbricano la bomba.
Il 22 marzo alcuni ragazzi del Gap rubano un carretto da spazzino e una divisa.
Il 23 tutto si realizza. Carla si recherà in via Rasella con quattro bombe a mano in una borsa. Ben Tivegna indosserà la divisa di netturbino e porterà il carretto con la bomba nel punto previsto. Al segnale convenuto, con il fuoco di una pipa accenderà la miccia. Quel giorno però la colonna si fa attendere. Fa ritardo. Aspettanocon grande ansia. Sono quasi le 16, stanno per decidere di mollare tutto, quando finalmente la colonna arriva. Franco Calamandrei si toglie il berretto per dare il segnale.
Il carrettino con il tritolo è adiacente a palazzo Fittoni. Rosario Bentivegna, travestito da netturbino, subito dopo il segnale convenuto, dà fuoco alla miccia. Affinché lo scoppio avvenga durante il transito della colonna, la miccia è della lunghezza necessaria perché duri poco meno di un minuto. Subito dopo lo scoppio, altri giovani lanciano le bombe e altri sparano con le pistole. Fiorentini, dato fuoco alla miccia, si allontana in fretta, e più avanti all’angolo della strada un altro gappista, Carla, gli fa indossare un impermeabile in sostituzione della divisa di netturbino. Muoiono subito 26 soldati, altri 6 durante la notte e un altro il giorno dopo. 33 saranno i morti. Muoiono tre civili, tra i quali anche un ragazzino di 12 anni che percorreva quella via. A seguito dell’impazzata sparatoria dei tedeschi, muoiono altri 6 civili. C’è fra i deceduti un poliziotto che era intervenuto con pistola in mano a sostegno dei tedeschi, fu scambiato per un partigiano e ucciso, era l’autista del questore Caruso.
Subito dopo l’attentato arriva in via Rasella il generale Mlelzer, Comandante tedesco di Roma. Era nel frattempo arrivato il Comandante delle SS Dolmar, che si accorge che Melzer è ubriaco. Melzer propone di fare saltare tutta via Rasella, ma Dolmar ritiene la proposta assurda. Hitler informato, vuole uccidere 50 italiani per ogni tedesco morto. Ma alla fine, dopo mediazioni, decidono per 10 per ogni tedesco ucciso.
Questa è la storia, esposta in breve e sicuramente lacunosa, ma corretta, dell’attentato.
L’azione di via Rasella ha suscitato tanto dibattito e polemiche. Anche la magistratura fu più volte chiamata a decidere su eventuali responsabilità penali degli attentatori. La magistratura, sollecitata, da congiunti delle vittime delle Fosse Ardeatine, che hanno ritenuto l’attacco a Via Rasella sbagliato, per la conseguente rappresaglia che ha provocato alle Fosse Ardeatine, ha sempre ritenuto i fatti di via Rasella, legittima azione di guerra partigiana.
Infatti, tutte le azioni partigiane provocano rappresaglie, in ogni parte del mondo. È un pericolo contemplato. Le rappresaglie sono evitabili, solo se cessano le azioni partigiane. La guerra partigiana,purtroppo, non può fare a meno di coinvolgere la popolazione tutta. È da imbecille chiedere al partigiano, dopo avere compiuto un atto di guerra, per evitare rappresaglie di costituirsi: non esisterebbe la Resistenza.
Riporto lo stralcio della lettera che Giorgio Amendola, il primo responsabile dell’attentato di via Rasella, più volte chiamato a spiegare, inviò il 12 ottobre 1964 a Leone Cattani, esponente liberale della resistenza.
“La più grossa responsabilità morale che abbiamo dovuto assumere nella guerra partigiana è quella dei sacrifici che si provocano, non soltanto i compagni di lotta che si inviano incontro alla morte – essi hanno scelto liberamente quella strada – ma gli ignari che possono essere colpiti dalle rappresaglie. Se non si supera questo tremendo problema non si può condurre la lotta partigiana. Noi del C.L.N.., tutti, anche se nella pratica con maggiore o minore convinzione, sapemmo superare questo problema. E prenderci le necessarie responsabilità. Soltanto dei pavidi o degli ipocriti potevano far finta di non comprendere le conseguenze che derivavano dalla posizione assunta. Affrontammo il rischio nell’unico modo possibile: non farci arrestare dal ricatto delle rappresaglie e, in ogni caso, rispondere al nemico colpo su colpo e continuare la lotta. L’annuncio della strage delle Ardeatine fu dato il 26 marzo (o 25 che fosse) a esecuzione compiuta, senza che nessun appello fosse stato lanciato ai responsabili dell’attentato perché si presentassero al comando tedesco o alla polizia fascista. Ma io non mi sono mai trincerato dietro questo dato di fatto, di fronte alla campagna condotta contro di noi da parte fascista con tutti i mezzi e anche in sede giudiziaria. Ho invece più volte dichiarato che, anche se l’appello fosse stato lanciato dal comando germanico, noi responsabili del comando GAP, e gli eroici combattenti che avevano attuato l’ardita operazione di guerra, non avevamo in alcun caso il diritto di presentarci, di consegnare, cioè, al nemico un comando partigiano e un reparto d’assalto. A parte ogni motivazione personale, non avevamo il diritto di decapitare il movimento partigiano, e di mettere in pericolo la sicurezza del movimento clandestino….”

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736










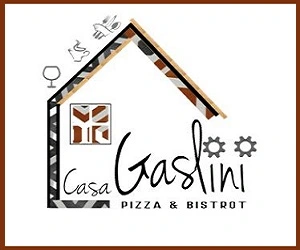



.webp)


