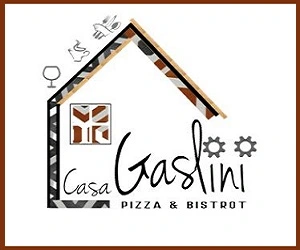Bulotta (M.E.I.C): "Basta con la politica degli insulti, delle offese e contumelie, ripristiniamo il confronto e il dialogo"




21 agosto 2025 10:21
di LUIGI BULOTTA*
L’ignobile aggressione sui social network subita dall’onorevole Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’Interno, nonché autorevole esponente di Fratelli d’Italia, fa tornare alla ribalta il fenomeno, in progressivo peggioramento, del degrado del linguaggio, scritto e parlato, moltiplicato in modo preoccupante, dall’uso o, meglio, dall’abuso, dei social.
Ma un altro inquietante fenomeno, sempre più diffuso, non solo in Italia, ma un po' in tutto il mondo, è costituito dal degrado del linguaggio con cui la politica comunica. Tutti, sia pure in varia misura, fanno a gara ad alzare i toni, a rendere il messaggio più forte colorendolo con attacchi sul piano personale e, addirittura con insulti all’avversario politico concepito come un nemico, un pericolo pubblico, una minaccia sociale, in questo modo allertando l’opinione pubblica anziché rassicurala, dal momento che l’obiettivo è solo quello di fare audience e ottenere consensi. Questo fenomeno è ormai diffuso ad ogni livello istituzionale, dai sindaci a parlamentari e ministri. Assistiamo alla pandemia del turpiloquio; a tutte le ore del giorno e della notte le male parole arrivano volgari, sporche, spinte, oscene, indecorose. Non solo gli insulti ma anche le sue fangose varianti come contumelie, calunnie, esecrazioni, improperi, offese, sberleffi.
Abbiamo assistito a queste sceneggiate nelle ultime, squallide campagne elettorali, sia in Italia che in Europa e negli Stati Uniti, con slogan, insulti personali e falsità camuffate da promesse di ogni genere, facendo conto della scarsa memoria degli elettori.
Perché questo fenomeno ha preso piede e sempre più si diffonde? Senza dubbio il linguaggio diretto e personalistico, condito da insulti e parole d’odio, la gestualità, l’alzare la voce, è un modo che i politici utilizzano per farsi sentire più vicini alla gente; rileva anche la bassa qualità della leadership politica e, non meno importante, è la crisi culturale che sta attraversando la società italiana nel suo complesso, essendo venuti meno riferimenti culturali comuni, nonchè diventata sempre meno diffusa la pratica della lettura.
Tutto ciò ha avuto un impatto negativo anche sul linguaggio politico che riflette e incrementa la tendenza alla superficialità. Un tempo i discorsi dei politici erano predisposti con grande cura e si ispiravano alle ideologie dei partiti, oggi pressoché inesistenti, nonché a modelli letterari e retorici elevati. Al contrario, oggi, prevalgono discorsi, spesso improvvisati, con frasi spezzate, neologismi di dubbio gusto e un uso improprio dei termini tecnici, essendo venuta meno la formazione che, un tempo, era ritenuta indispensabile per la classe politica.
Ormai la retorica e la capacità di argomentare non sono più considerate competenze fondamentali per chi entra in politica, rilevando l’immagine che ognuno riesce a crearsi unita alla cosiddetta capacità di “bucare” lo schermo. Questa mancanza di preparazione si riflette sicuramente sulla qualità del linguaggio che sta passando alla brutalità più assoluta con lo scopo di acquisire sempre maggiore consenso dagli elettori, con il rischio, a volte già verificatosi, che la violenza verbale si traduca in violenza fisica e venga sempre meno la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel sistema democratico. Infatti, già ora, il grado di fiducia dei cittadini nei confronti dell’azione politica e della sua capacità di rappresentare fedelmente e degnamente l’elettorato e di incidere positivamente nel contesto socioeconomico è molto basso.
Tutto ciò ha determinato lo spostamento da un voto di appartenenza a un voto libero di opinione, anche in conseguenza della crisi delle ideologie dei grandi partiti di massa. Infatti, si è passati da una lingua colta ed elitaria, a una più semplice e popolare e il dialogo e il confronto vengono percepiti come una noiosa perdita di tempo. Tutto, ormai, viene ricondotto allo schema amico/nemico, alla guerra di tutti contro tutti, cercando un consenso sempre più umorale e, quindi, mobile e emotivo. La mediazione e la predisposizione al dialogo vengono considerati démodé. La mentalità demagogica si coniuga molto bene con queste modalità comunicative brevi, evocative, che non ammettono replica. Viene così ammesso un modo di pensare che si fonda sulla dicotomia: chi vince e chi perde, maggioranza e opposizione; vero e falso, amico e nemico, il tutto in un clima di campagna elettorale permanente dovuto all’estrema mobilità del consenso, rilevata attraverso sondaggi continui che condizionano e determinano le scelte della politica, i rinvii delle decisioni, i programmi.
In questo contesto assistiamo inermi al degrado del linguaggio politico con il suo progressivo impoverimento che oscilla tra la derisione, l’insulto, l’aggressione con brevi frasi ad effetto e con formule mediaticamente attraenti, nonché con frasi, dichiarazioni che a volte vengono smentite dall’interessato anche dopo pochi minuti dall’averle pronunciate.
I social media hanno la responsabilità di amplificare il degrado linguistico. Questi strumenti, pur avendo, da un lato, il potenziale di avvicinare i cittadini alle istituzioni, spesso incentivano un linguaggio semplificato, aggressivo e polarizzante. La brevitas richiesta da piattaforme come Twitter o TikTok spinge i politici a sacrificare la complessità e la profondità del discorso in favore di slogan accattivanti e frasi a effetto, che mirano più a suscitare emozioni immediate che a promuovere una riflessione consapevole. In cerca di audience, i talk show politici tendono a premiare i protagonisti più polemici e a ridurre gli spazi per un confronto ragionato.
Questo circolo vizioso alimenta ulteriormente il degrado del linguaggio politico, poiché i politici si vedono stimolati ad adottare stili comunicativi sempre più estremi, che alla fine si ritorcono contro chi li usa. Come scrisse il noto filosofo Soren Kierkgaarsd “proprio per mezzo del linguaggio un uomo può degradare sé stesso”.
Questo linguaggio si caratterizza per una semplificazione eccessiva dei problemi, l’uso di metafore bellicose e la delegittimazione sistematica degli avversari. Il risultato è un clima di conflittualità permanente che indebolisce, se non elimina, il dialogo democratico. Sono mutati i contesti le occasioni, i formati comunicativi e gli strumenti di dialogo: si è passati dai comizi ai video postati su Facebook, Instangram, Twitter, Questi cambiamenti, secondo molti, sono vere e proprie involuzioni.
Cosa fare? Il degrado del linguaggio politico è un fenomeno complesso che richiede un intervento su più fronti, sui quali anche la politica deve fare la sua parte. Come ebbe a scrivere il noto scrittore George Orwell, il degrado del linguaggio da parte di chi “lavora con le parole – politici, giornalisti, ecc., costituisce un concreto rischio per la tenuta delle nostre democrazie”. È giusto punire chi ha posto in essere comportamenti altamente offensivi, coloriti da insulti e minacce, ma occorre in parallelo promuovere una cultura politica più inclusiva e rispettosa, riformare i meccanismi di comunicazione istituzionale. Solo attraverso un’azione coordinata si potrà restituire dignità e valore al discorso pubblico, indispensabile per il buon funzionamento della democrazia. Gli insulti non sono argomenti e non è solo una questione di stile e di buona educazione, è una questione di democrazia. L’insulto sbarra la strada al confronto, al ragionamento, mentre per favorire la partecipazione bisogna dialogare.
La politica, nel vero significato della parola, non è gestione del potere, è servizio alla collettività. Secondo la dottrina sociale della Chiesa, alla quale il M.E.I.C. si rifà nello svolgimento della sua attività, la politica è uno strumento per promuovere il bene comune inteso come il complesso delle condizioni sociali che permettono a tutti i membri della società di raggiungere il proprio pieno sviluppo, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, per la salvezza della società con uno sguardo al futuro. Comportamenti e azioni non coerenti con il vero ruolo che la politica deve svolgere nel contesto sociale vanno deprecati e condannati.
E’ giusto e doveroso, come è avvenuto, esprimere la solidarietà all’on,le Ferro, per quanto ha subito, nonchè la condanna di questi oltremodo deprecabili comportamenti; solidarietà e condanna che anche noi come M.E.I.C. con convinzione esprimiamo; ma è altrettanto giusto e doveroso che la politica metta in campo iniziative e attivi strumenti atti a contenere questo indecente fenomeno del linguaggio offensivo e scurrile che, se viene usato da chi ricopre cariche istituzionali, svilisce le istituzioni che rappresentano e svilisce lo stesso Stato.
L’occasione per intervenire potrebbe essere costituita dalle ormai prossime elezioni del presidente e del consiglio regionale della Calabria. Sarebbe un forte segnale di cambiamento se le forze politiche che parteciperanno alle consultazioni adottassero un codice di comportamento da far sottoscrivere ai loro candidati impegnandoli a garantire valori elettorali fondamentali quali l'integrità, la trasparenza, la riservatezza, la sicurezza, la veridicità, la correttezza nelle proprie strategie di comunicazione, basando la campagna elettorale su serie e praticabili proposte e progetti e non sul discredito degli avversari, in ogni caso vietando insulti, ingiurie, insolenze, nonché il raggiro deliberato degli elettori con informazioni devianti.
Come M.E.I.C., comunque, gridiamo a gran voce “basta con gli insulti, le offese, le contumelie, e l’insolenza, vogliamo una politica che si basi sul dialogo e sul confronto costruttivo e democratico, in cui ognuno esprima serenamente ma anche con determinazione le proprie idee e i propri programmi nel rispetto della dignità dell’uomo e dei rispettivi diritti. Possono servire le urla, quando c’è n’è bisogno, a patto di non varcare mai la misura”.
* Presidente M.E.I.C. Catanzaro-Squillace

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736








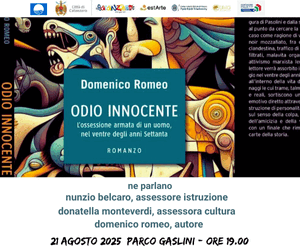
.webp)