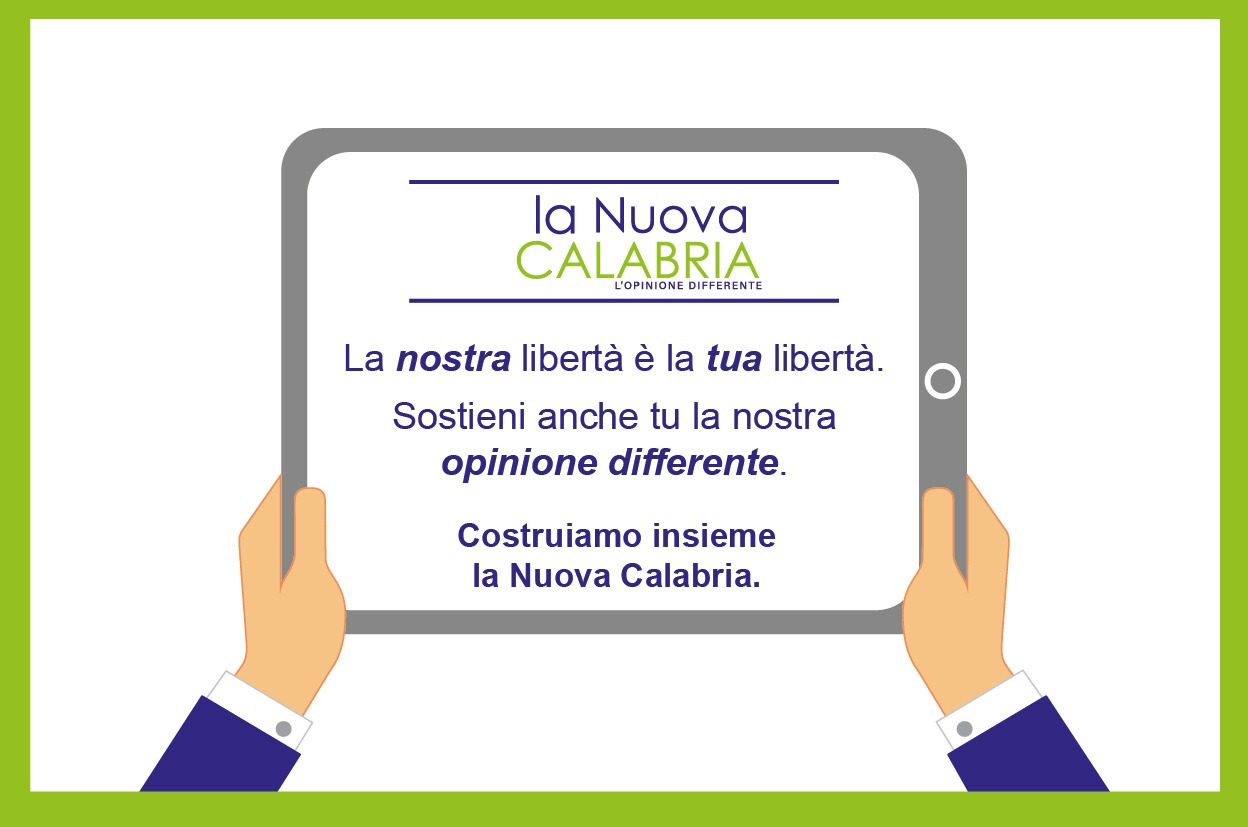Catanzaro, al Politeama va in scena “Metadietro” di RezzaMastrella: l’intervista




27 gennaio 2026 10:05
di CARLO MIGNOLLI
Ironici, caustici, irriducibili a qualsiasi etichetta, RezzaMastrella tornano a interrogare il presente con Metadietro, la nuova creazione che venerdì 30 gennaio 2026 approda per la prima volta al Teatro Politeama di Catanzaro, nell’ambito della stagione teatrale diretta dalla Sovrintendente e Direttrice Artistica Antonietta Santacroce. Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2018, Antonio Rezza e Flavia Mastrella continuano a praticare quella che definiscono “comunicazione involontaria”, un teatro che non consola e non rassicura, ma espone corpi, idee e contraddizioni al rischio costante dell’abisso.
In Metadietro, scritto da Antonio Rezza e con gli habitat scenici di Flavia Mastrella, un ammiraglio vestito di blu elettrico tenta di salvare la propria nave - veliero e navicella spaziale insieme - mentre l’equipaggio, accecato da logiche di mercato e interessi individuali, procede alla deriva. Nessun colpevole, nessuna salvezza certa: solo il divario insanabile tra modi diversi di stare al mondo, tra il desiderio di ammutinamento e l’impossibilità di tornare a una dimensione naturale e selvaggia.
Rezza e Mastrella si sono raccontati ai nostri microfoni alla vigilia di questa tappa calabrese per attraversare con loro l’universo visionario di Metadietro: un viaggio tra comicità crudele e ferocia poetica, dove la tecnologia divora l’eroe, la realtà scombina ogni programma prestabilito e la fantasia resta l’unica forza capace di resistere al naufragio dell’umano.
L’INTERVISTA
Metadietro è un titolo enigmatico, quasi uno spostamento di prospettiva. Ti chiedo innanzitutto cosa significa oggi “andare dietro”, in un tempo che sembra correre sempre e solo in avanti.
AR: «Il problema non è andare dietro. Il problema è chi sta davanti e il fatto che ci sia qualcuno dietro. Con tutte le metafore possibili. Ogni nostro spettacolo affronta il paradosso della fregatura: c’è sempre qualcuno che, travestito da potere o da gerarchia, riesce a stare dietro. E stando dietro si agisce alle spalle di chi sta davanti. Il problema, quindi, è guardarsi alle spalle. Che non significa guardare al passato, ma accorgersi che chi ha meno coraggio preferisce nascondersi. Tutto qui, se vogliamo trovare un significato politico, generazionale, etico».
Quindi “meta” può indicare più direzioni insieme?
FM: «Sì, è tutto insieme, come sempre. Anche perché noi siamo dei tramiti: viviamo la realtà e la restituiamo in base ai nostri umori. È una realtà critica, ma anche interiore. Politica e interna allo stesso tempo».
C’è anche una riflessione sull’essere umano?
AR: «Noi viviamo male perché abbiamo persone alle spalle. Se le avessimo tutte davanti non cambierebbe nulla, perché saremmo noi a stare dietro. L’essere umano non ha molte prospettive, ma questo si sa da sempre, da quando si è abbattuto sulla faccia della Terra. Se guardiamo persino alla gastronomia, noi non siamo niente».
Venendo alla scena, troviamo un ammiraglio impegnato a salvare la propria nave, ostacolato però dall’equipaggio, prigioniero di logiche di mercato e interessi individuali. Quanto questa metafora parla del presente che stiamo vivendo?
AR: «Noi nel presente non crediamo molto. Lo analizziamo perché ne siamo vittime, siamo messi al centro di ciò che accade. Il nostro presente è sempre antimperialista, sempre antiamericano, perché da lì partono i disequilibri dell’assetto mondiale, anche se oggi ci vogliono far credere che esistano poli alternativi in grado di scalfire un’egemonia storica. Parliamo comunque di esseri umani, quindi di niente».
FM: «Lo spettacolo parla della situazione attuale. In scena c’è un pentagono che si trasforma in base alle esigenze politiche del momento: va in mare, va sulla luna, diventa un’astronave, una canoa. Diventa molte cose che hanno a che fare con il nostro quotidiano».
È una posizione molto netta.
AR: «Sto operando un distacco che mi fa vedere progressivamente come ridicole le persone che comandano: esseri inferiori che cercano di dettare condizioni a chi ritengono più inferiore di loro. Non li ascolto più. Per me un governante non vale niente rispetto a un artista. Un artista fa dalla mattina alla sera quello che vuole: è un privilegiato. Un governante che deve fare quello che vogliono gli altri è un poveraccio. Io li vedo così, poveracci. Non hanno alcuna ascendenza su di me. Siamo purtroppo amministrati da poveracci. E quindi sì, naturalmente c’è una parte politica nello spettacolo».
É uno spettacolo più politico o più esistenziale?
AR: «È già politica la nostra posizione. Noi non prendiamo soldi statali per produrre le opere. Lavoriamo al Vascello di Roma, una realtà poco finanziata. Non costiamo nulla allo Stato quando debuttiamo: questo è un punto di vista fortemente politico. In un momento in cui l’arte sembra dover essere per forza finanziata, io spero quasi che questa destra riesca a fare una cosa buona: affamare completamente l’arte. Quella che pensa di essere arte. Perché noi siamo tutti una grande destra, purtroppo. Viviamo sotto un fascismo eterno. Non esiste più la sinistra che uno amava da giovane. Esiste solo un totalitarismo».
È anche un dialogo tra digitale e fisico?
FM: «Sì, perché l’arte digitale è molto affascinante, ma spesso è difficile da manipolare a livello di contenuto: il fascino estetico tende a distrarre dal significato. Io sto cercando di capire come inserire un contenuto dentro la fascinazione, facendo questo gioco di trasferimento dal digitale alla materia».
Parliamo invece dell’habitat ideato proprio da Flavia Mastrella. Che funzione ha nel racconto scenico e come nasce?
FM: «L’ho ideato seguendo le pulsioni del momento. In questi anni ho lavorato molto con la realtà virtuale e con allestimenti immersivi, e questo mi ha permesso di maturare una riflessione sull’arte digitale. Poi ho tradotto quel concetto in materia, per il nostro lavoro teatrale».
AR: «Flavia realizza uno spazio per se stessa e io ci vivo dentro per un anno, un anno e mezzo, insieme a Daniele Cavaioli e a Massimo Camilli, nostro collaboratore storico. Stiamo chiusi lì a farci venire delle idee. Per me l’habitat è una seconda casa. Ma di questo parla meglio lei. Abbiamo sempre lavorato sulla rielaborazione dello spazio».
Anche le luci hanno un ruolo importante.
FM: «Sì, è un lavoro molto evoluto anche dal punto di vista delle luci. Il disegno luci è di Alice Mollica. È stato un lavoro complesso e impegnativo, ma molto interessante, perché l’habitat ha sapori naturali e allo stesso tempo completamente artificiali. E Antonio lo attraversa con la sua grande mobilità».
Arrivate per la prima volta al Teatro Politeama di Catanzaro. Che valore ha per voi debuttare in una città del Sud che non avevate mai esplorato?
AR: «È un mistero per noi. L’Italia è piccola, è nulla rispetto al pianeta Terra, figuriamoci rispetto all’universo. Non riusciamo a spiegarci perché non si riesca a venire più spesso al Sud. Le stagioni teatrali si fanno, ma mancano gli ideali. È un’eresia che siamo stati nove anni senza venire in Calabria. Catanzaro è la prima volta. Siamo felici, perché per noi ogni spettacolo è come fosse l’unico. Ma bisognerebbe venire più spesso».
FM: «È sempre un piacere tornare in Calabria, anche se non è mai semplice. C’è sempre qualche difficoltà, qualche problema, ma resta comunque un piacere».
Dipende anche dalle scelte artistiche?
AR: «Dipende molto dai direttori artistici e spesso dagli assessori, in tutta Italia. Giudicano le opere troppo innovative e presuppongono che il pubblico non capisca, dandogli la patente da deficiente. Ma nessuno è deficiente. È gravissimo mancare nove anni dalla Calabria. È più facile andare in Cina, in Lituania o a New York che fare uno spettacolo in Calabria. È assurdo».
Per voi che avete iniziato a lavorare alla fine degli anni ‘80, quanto è cambiato il pubblico rispetto a quel periodo?
FM: «Gli aspetti negativi noi non li vediamo molto, perché diamo una forma e un contenuto che il pubblico percepisce quasi sempre in modo felice. La cosa che ho notato di più è che oggi il pubblico capisce molto meglio il linguaggio dell’immagine. Prima sembrava che l’immagine li spiazzasse».
Quindi oggi c’è una maggiore alfabetizzazione visiva?
FM: «Sì, soprattutto tra i più giovani. I ragazzi di sedici anni comprendono completamente il discorso, perché parlano un linguaggio visivo. L’habitat è costruito in modo strutturale, studiando la comunicazione, e loro percepiscono sia l’aspetto formale che quello fisico, verbale e corporeo».
Il vostro rapporto dura da oltre trentacinque anni. Come si è trasformato nel tempo senza diventare ripetitivo?
AR: «Non è un rapporto sentimentale, e questo aiuta molto. È qualcosa di più: un rapporto speculativo. Si basa sull’indipendenza e sulla coerenza dell’altro. Nessuno dei due si metterebbe mai in vendita. Questo rafforza la bellezza di ciò che facciamo. Se un giorno facessimo cose brutte, il rapporto si arresterebbe. Finora ha funzionato tutto sul reciproco: sulla destrezza, sulla capacità di stupire l’altro».
FM: «Credo perché ognuno di noi ha maturato la propria libertà. Antonio ha scritto libri, io ho fatto allestimenti: siamo indipendenti. Quando lavoriamo insieme, ognuno porta un’esperienza nuova, e questo rende il lavoro e il rapporto sempre freschi. In un rapporto, anche amoroso, se si sta sempre troppo vicini ci si blocca. Un rapporto deve respirare».
Qual è lo spettacolo che avete più a cuore o considerate magari la svolta della vostra carriera?
FM: «È difficile dirlo, sono come figli. Photofinish, 7-14-21-28: tutti raccontano momenti importanti della nostra vita e della cultura che ci circondava. Ma non pensiamo mai di aver fatto una svolta. Siamo pessimisti, sempre un po’ arrabbiati, non ci sentiamo mai “arrivati”».
Per concludere: avete attraversato teatro, cinema, cortometraggi, ricevendo anche premi importanti. In quale di questi mondi vi sentite più a casa?
AR: «Il cinema è il linguaggio più completo, anche se - come dice Franco Maresco - il cinema è finito. Permette di aggregare arte contemporanea, drammaturgia, performance, veste visuale, inquadratura. Ma la cultura occidentale non permette a persone libere di fare cinema davvero. Per questo abbiamo curato di più il teatro, un teatro di montaggio, come ritmo, come musica tribale. Con il teatro abbiamo finanziato il cinema, la letteratura, tutto. Nessun rimpianto: abbiamo sempre fatto tutto. Se il mondo fosse stato più giusto, forse sarebbe andata diversamente. Ma il mondo non può essere giusto. E va bene così».
FM: «Ognuno arricchisce l’altro. Sono sempre state esperienze che hanno nutrito il teatro, e il teatro ha nutrito il cinema. È una ricerca continua di nuove forme di comunicazione».
Segui La Nuova Calabria sui social

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019
Direttore responsabile: Enzo Cosentino
Direttore editoriale: Stefania Papaleo
Redazione centrale: Vico dell'Onda 5
88100 Catanzaro (CZ)
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Sirinfo Srl
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 3508267797