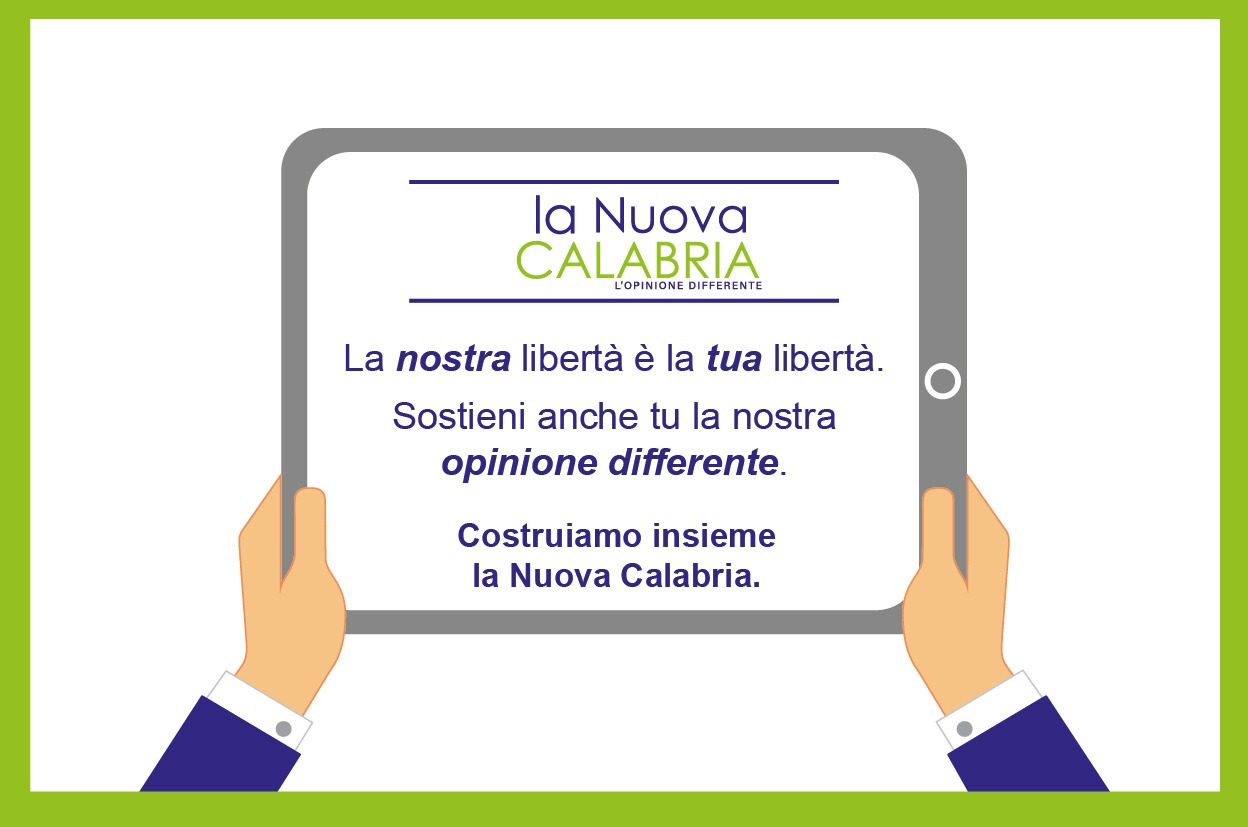Catanzaro, l’avvocato Conidi: “Quando la sicurezza digitale della giustizia diventa una questione di fiducia”




01 febbraio 2026 14:16
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
Qualche tempo fa avevo scritto che la polemica sul portatile personale del procuratore Nicola Gratteri era, in fondo, una discussione fuori fuoco. Oggi, alla luce delle rivelazioni sul software ECM installato nei computer del Ministero della Giustizia e dell’indagine aperta nei confronti del tecnico che ne ha dimostrato le potenzialità in una trasmissione televisiva,(Report) quella riflessione assume un valore che qualcuno potrebbe definire persino profetico. Perché il punto non era, e non è mai stato, il computer di un singolo magistrato. Il punto è il sistema.
La vicenda ECM ha spostato improvvisamente il baricentro del dibattito: non più il magistrato che lavora con un portatile proprio, ma la possibilità che i computer istituzionali, quelli forniti dallo Stato, possano essere raggiunti da remoto attraverso funzioni tecniche non percepite dall’utente finale. È un cambio di prospettiva radicale. Se l’ipotesi investigativa dovesse essere confermata, ci troveremmo davanti a un paradosso: mentre si discute della legittimità di strumenti “personali”, emerge il sospetto che quelli ufficiali possano essere, in determinate condizioni, più esposti di quanto si voglia ammettere.
Chi lavora nei palazzi di giustizia sa bene che l’attività quotidiana del magistrato è ormai interamente digitale. Atti, fascicoli, banche dati, notifiche, comunicazioni con le cancellerie e con le forze di polizia passano attraverso piattaforme ministeriali centralizzate, credenziali nominali, protocolli e sistemi di tracciamento. Il dispositivo – fisso o portatile, istituzionale o personale – è solo l’interfaccia. Il cuore vero del potere, e del rischio, sta nella infrastruttura informatica che governa l’accesso ai dati e ai flussi di lavoro.
In questo senso, la polemica originaria sul computer di Gratteri appare oggi quasi rovesciata. Se un magistrato utilizza un portatile proprio, il tema non è tanto la “proprietà” dell’hardware, quanto la conformità dell’accesso alle reti e ai sistemi ufficiali: autenticazione, cifratura, log, segregazione dei privilegi, certificazione dei canali di comunicazione. Sono questi gli standard che fanno la differenza tra un sistema sicuro e uno vulnerabile, non la marca o la provenienza del computer.
L’indagine sul tecnico che ha mostrato in televisione le potenzialità di ECM solleva però una domanda più scomoda: lo Stato ha testato fino in fondo i propri strumenti prima di affidarli ai magistrati? È una questione di metodo prima ancora che di responsabilità penale. In qualsiasi infrastruttura critica – dalla finanza all’energia, dalle telecomunicazioni alla difesa – la sicurezza informatica si fonda su audit indipendenti, penetration test, verifiche periodiche e simulazioni di attacco. La giustizia, che gestisce informazioni sensibili quanto e più di questi settori, dovrebbe essere sottoposta a standard analoghi.
Da qui nasce una frattura che va oltre il caso specifico: quella tra la fiducia istituzionale e la percezione di vulnerabilità. Quando emerge l’idea che un sistema possa essere “forzato” o aggirato, anche solo in teoria, non è solo un problema tecnico. È un problema politico e culturale, perché mette in discussione la solidità dell’architettura su cui si regge l’intero impianto giudiziario. E in un contesto in cui si indagano criminalità organizzata, corruzione, terrorismo e grandi interessi economici, la sicurezza digitale non è un accessorio: è una condizione di legittimità.
Questo discorso si estende, forse ancora più drammaticamente, al tema delle audizioni e degli interrogatori da remoto, pratica divenuta comune dopo la pandemia. Qui il rischio non riguarda solo l’accesso ai computer, ma la genuinità stessa della prova. In un’aula fisica, la presenza è visibile, controllabile, verificabile. A distanza, tutto si regge su un presupposto di correttezza tecnica e procedurale: chi ascolta è davvero chi deve ascoltare, nessuno registra, nessuno diffonde, nessuno è “dietro lo schermo”.
Nel caso dei collaboratori di giustizia, questo presupposto diventa una questione di sicurezza personale oltre che processuale. La riservatezza non è una formalità, ma una garanzia di sopravvivenza. Se il canale tecnologico non è certificato, se l’ambiente digitale non è blindato, ogni interrogatorio a distanza apre una zona grigia in cui la fiducia sostituisce il controllo, e la buona prassi prende il posto della verifica tecnica.
La vera domanda, oggi, non è se un magistrato debba usare un computer proprio o uno fornito dal Ministero. La vera domanda è se l’infrastruttura digitale della giustizia italiana sia progettata, testata e monitorata con lo stesso livello di rigore che lo Stato pretende dai suoi magistrati quando amministrano la legge.
Perché se lo Stato mostra l’anello più debole proprio nel settore in cui chiede il massimo livello di fiducia, il rischio non è solo un incidente informatico. È un’erosione silenziosa della credibilità delle istituzioni. E quella, a differenza di un software, non si aggiorna con una semplice patch.
Una conclusione oltre la tecnica
C’è infine un livello più profondo, che va oltre software, audit e protocolli, e riguarda il rapporto tra tecnologia e responsabilità umana. La giustizia del passato si reggeva in larga parte sulla filiera delle persone: il cancelliere, il giudice istruttore, la richiesta formale, la firma, la carta. Un sistema certamente imperfetto, ma in cui l’errore, la negligenza o la malafede avevano un volto riconoscibile. Oggi la fiducia viene progressivamente trasferita dalla persona al processo digitale, dalla responsabilità individuale all’architettura informatica.
Il paradosso è evidente: ci si affida alla macchina per ridurre l’arbitrio umano, dimenticando che la macchina è a sua volta progettata, amministrata e governata da esseri umani. E come tale, resta fallibile, opaca, potenzialmente manomettibile. La sicurezza non può essere solo una questione di sistemi, perché nessun sistema è eticamente neutro: dietro ogni infrastruttura ci sono scelte, priorità, controlli e poteri.
Se la digitalizzazione della giustizia non viene accompagnata da una cultura della trasparenza, della responsabilità e della verifica pubblica, il rischio non è solo tecnico, ma istituzionale. Non si tratta di rimpiangere la carta o il passato, ma di ricordare che nessuna tecnologia può sostituire i valori di dignità morale, onestà intellettuale e controllo democratico su cui, in ultima analisi, si fonda la credibilità dello Stato di diritto.
In questo quadro, non può passare inosservata l’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario, celebrata con il consueto apparato di cerimonie, discorsi ufficiali e ritualità solenni. Una liturgia che richiama la tradizione e il prestigio delle istituzioni, ma che rischia di suonare vuota se messa a confronto con le fragilità strutturali che emergono sul piano tecnologico e organizzativo. La distanza tra la pompa magna delle forme e la concretezza dei problemi – sicurezza informatica, trasparenza dei sistemi, garanzie sulle audizioni a distanza, protezione effettiva dei dati sensibili – diventa, in questo contesto, difficile da ignorare.
Il rischio è che la solennità delle cerimonie finisca per funzionare come una cortina simbolica, dietro cui restano irrisolte le questioni che incidono davvero sulla credibilità quotidiana della giustizia. Perché la fiducia dei cittadini non si costruisce con i rituali, ma con la percezione che le istituzioni sappiano riconoscere le proprie vulnerabilità e affrontarle in modo aperto, verificabile e responsabile.
In definitiva, il dibattito aperto dal caso ECM e dalla polemica sul portatile non può essere archiviato come una disputa tecnica tra addetti ai lavori. È una questione che tocca il rapporto tra cittadini e istituzioni, tra potere e controllo, tra fiducia e verifica. La giustizia digitale non è solo un insieme di server, software e credenziali: è un nuovo spazio pubblico in cui si esercita una parte fondamentale della sovranità dello Stato. E come ogni spazio di potere, deve essere visibile, controllabile e rendicontabile.
Perché la vera modernità della giustizia non si misura in terabyte o in piattaforme, ma nella capacità di garantire che, anche dietro uno schermo e dentro un sistema informatico, continuino a valere gli stessi principi che dovrebbero reggere un’aula di tribunale: responsabilità, trasparenza e uguaglianza di fronte alla legge.
*Avvocato
Segui La Nuova Calabria sui social

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019
Direttore responsabile: Enzo Cosentino
Direttore editoriale: Stefania Papaleo
Redazione centrale: Vico dell'Onda 5
88100 Catanzaro (CZ)
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Sirinfo Srl
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 3508267797