Cimino: “Catanzaro, la sua piccola piazza delle bandiere della pace al vento: la politica come risposta”



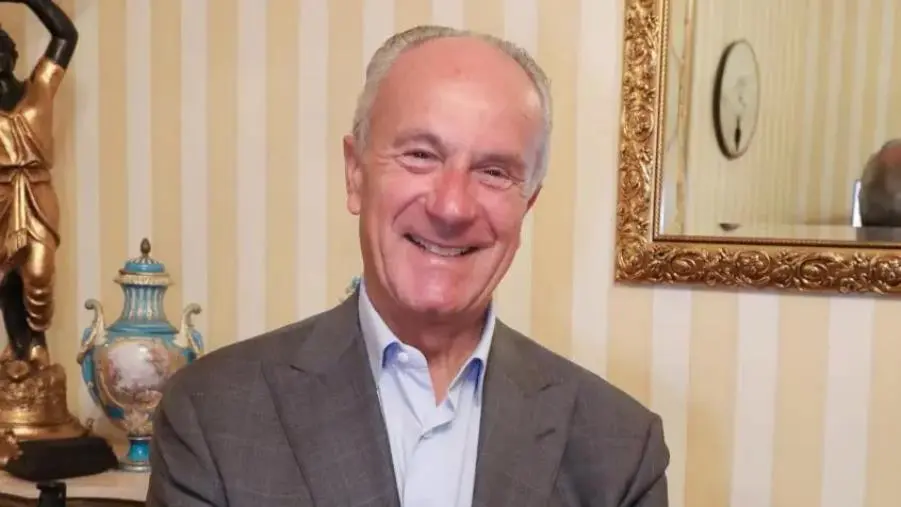
03 ottobre 2025 19:05
di FRANCO CIMINO
La piazza è quella che, pur ignorata da molti – in particolare da quanti hanno amministrato la città in questi ultimi quarant’anni e oltre – unisce o separa due parti di Catanzaro, a seconda dei punti di vista e delle visioni che si hanno sulla città. Piazza Matteotti, che non è mai stata considerata né piazza né bella, e che forse davvero non è né una piazza né bella, collega due parti della città: il centro storico, con la sua affascinante antichità, e la parte che si muove verso l’alto. Quella che avrebbe voluto essere, dopo demolizioni purtroppo sciagurate, la “testa moderna”, capace di dare un volto urbanisticamente nuovo ma pulito a un territorio che cercava di rinascere.
In particolare, la zona che sale da piazza Stocco, piccola e rotonda, lungo via Milano, San Leonardo e via via fino al primo monte di Catanzaro, Sant’Elia, dove l’aria è ancora più salubre e piacevolmente fresca, anche nelle estati più accese. Oggi questa posizione urbanistica di collegamento acquista un significato diverso, più particolare: quello di unire le coscienze divise della nostra popolazione, se così possiamo definire gli abitanti del capoluogo.
L’occasione è stata il raduno, in quella piazza “non piazza”, dei manifestanti a favore della liberazione della Palestina. Ovvero di ciò che resta di Gaza e dei suoi tre milioni, forse più, di abitanti. Proprio oggi iniziava lo sciopero generale, che proseguirà domani, indetto dalla Cgil e da altre sigle sindacali, sulla questione palestinese e sulla dura opposizione nei confronti di Israele, che da due anni sta massacrando e sterminando il popolo palestinese.
A questo motivo si è aggiunta la protesta contro il blocco navale imposto dalla marina israeliana alle cinquanta piccole e disarmate imbarcazioni della Flotilla, quel piccolo esercito di volontari che, in navigazione da sette giorni, aveva come obiettivo – già comunicato sin dall’inizio – raggiungere la Striscia di Gaza per portare viveri e medicinali alla popolazione affamata, tentando di salvare almeno un po’ di bambini denutriti e a rischio di morte. E per dimostrare al mondo intero che l’illegale occupazione di terre altrui da parte di Israele non è soltanto inaccettabile, ma un atto di grave minaccia al diritto internazionale – per quanto esso possa essere discusso da qualcuno distratto o ignorante – e alla Carta dei diritti universali, nella quale resta fermo il diritto dei popoli e delle persone di vivere liberamente e in pace nella propria terra.
E per dimostrare altresì che, se i territori possono anche essere assurdamente occupati e recintati, il mare no. Il mare, per sua natura, è libero. È spazio di liberazione, di comunicazione, di solidarietà. La legge principale del mare, scritta dal mare stesso, non riguarda solo il diritto di ciascun navigante – che si muova in pace e per la pace – a essere tutelato, non aggredito, non bloccato nel proseguimento della navigazione. Riguarda anche e soprattutto il diritto di rappresentarsi come via sicura per consentire di raggiungere e assistere persone e popoli che rischiano la vita e hanno bisogno di sostegno, materiale e politico.
La missione della Flotilla è stata sin dall’inizio una missione politica. Nella forma più alta della Politica. Perché salvare vite umane, liberare gli imprigionati, proteggere donne, bambini e anziani, lavare il sangue versato su territori innocenti, creare le condizioni perché la liberazione dei popoli consenta loro di vivere in pace nella propria terra e nello Stato cui hanno diritto, è la più alta forma di Politica.
Condannare le guerre – in particolare quelle anomale di un esercito potente, come quello israeliano, contro un popolo disarmato – è un atto politico. Lottare per dare uno Stato e un territorio ai popoli che ne hanno diritto, è un atto politico. Gridare un No forte e carico di indignazione morale contro la morte inflitta a uomini, donne e soprattutto bambini innocenti; dire un No deciso alla forza distruttiva che devasta città, paesi e campi, bruciando ogni possibilità di vita invece che far nascere il grano, è un atto politico.
Agire in questa direzione dai luoghi apparentemente più lontani da quei territori devastati è un atto politico ancora più importante, perché contiene quella grande carità di cui ha parlato un grande Papa della Chiesa cattolica.
Di tutto questo, oggi, in piazza Matteotti a Catanzaro si è parlato con canti e parole affidate a bandiere che, con l’aiuto del vento, sventolavano in direzione del Medio Oriente e verso il cielo della pace. Chi vi ha partecipato ha voluto dire o sentire tutto questo. Ha voluto fare Politica.
C’è stata pace in quella piazza e poi lungo il breve corteo che si è incamminato per il corso della Città. Canti e slogan, tranne pochissimi che personalmente non ho apprezzato, erano tutti belli, pacifici, pacifisti. Peccato che si fosse in pochi, poche centinaia, nel capoluogo di una regione che più di altre dovrebbe sentire questi profondi sentimenti. In particolare quello della liberazione da ogni prigionia, sudditanza, occupazione e predominio, da ogni forma di intolleranza e arroganza.
Dov’erano le tante scuole superiori e, perché no, anche medie ed elementari? Dov’erano le centinaia di ragazzi che in altre occasioni meno importanti abbandonano in massa gli istituti in nome di uno sciopero, ma che poi non si vedono nelle piazze? E dov’erano le centinaia di docenti, che di pace e libertà – come della negazione di ogni guerra e violenza – dovrebbero fare il prologo quotidiano di ogni lezione, qualunque sia la disciplina insegnata?
Dov’è quella scuola che dovrebbe essere palestra di formazione della coscienza democratica dei nostri giovani? Dov’è quella scuola come sede di cittadinanza attiva, oggi e durante il percorso scolastico, attraverso la quale scoprire il valore inalienabile dell’impegno di tutti a favore della democrazia e della libertà? Oggi questa realtà non si è vista. Ed è stato un vero peccato.
Specialmente se una parte è stata scoraggiata da una logica politica eccessivamente divisiva, che sul piano ideologico conserva rancore ma non ideali, pur se diversi e contrastanti.
La nostra Città deve recuperare la forza culturale che aveva. Deve ritrovare quel senso critico diffuso che ha animato il confronto – pur vivace – tra politici e intellettuali di diverso schieramento, poeti e letterati, scrittori e artisti, operai e disoccupati, giovani e meno giovani.
Catanzaro mostra qui la sua principale debolezza: quella che le ha fatto perdere ruolo e forza nell’intera regione. Una debolezza che la espone a due aggressioni intense: quella di chi non ama Catanzaro per stupidità politica e ignoranza del ruolo che il capoluogo deve esercitare in una regione che voglia uscire dalla propria debolezza antica; e quella, involontaria e dolorosa, di tanti giovani – seguiti poi dalle loro famiglie – che, sfiduciati e delusi, lasciano Catanzaro già a partire dagli studi universitari e difficilmente vi fanno ritorno.
Una Città che progressivamente si svuota continuerà a lasciare sempre più vuoto il famoso Corso Mazzini, che vorremmo si riempisse di persone, di giovani e di nuova luce. Continuerà a svuotare le sue piazze, e questa stessa piazza Matteotti rischia di cessare definitivamente di essere il felice rettangolo di collegamento e unione non soltanto di parti del territorio comunale, ma di generazioni e culture, di opzioni politiche e sentimenti.
Quelli che oggi avremmo voluto vedere tutti insieme, muoversi festosi e sognanti da questa piazza verso l’avvenire.
Un avvenire di prosperità. Di pace. Di libertà.

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736
© La Nuova Calabria 2019
Aggiornata al 03/10/2025 21:45:14













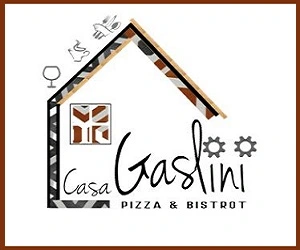



.webp)