E chiamiamola estate/4: anfore e tesori nei fondali del mare di Calabria




03 agosto 2025 08:04
di GIOVANNA BERGANTIN
Un misterioso naufragio risalente a 200 o a 300 anni prima Cristo e un tesoro custodito per secoli sul fondo del mare, al largo di Cetraro (costa tirrenica della Calabria): anfore di varie fogge, greche, romane e medievali.



«Una interessante collezione di anfore da trasporto arrivate da numerosi recuperi fortuiti dei pescatori del posto». Il direttore del Museo dei Brettii e del Mare, Luigi Orsino, descrive i tesori di una delle più belle realtà museali del mare - custoditi a Palazzo Del Trono nel centro storico di Cetraro - nato nel 2011 e parte del Sistema Museale Nazionale dei Musei non statali.
“Si tratta di anfore in terracotta di diverse tipologie ed epoche, in particolare ellenistica e romana, prodotte in differenti officine del Mediterraneo riferibili per lo più a imbarcazioni, - spiega Orsino - probabilmente naufragate durante fortunali nei tratti più insidiosi del mare. La presenza nelle acque locali di questi antichi relitti carichi di reperti anforici, che da millenni giacciono disseminati sul fondo, rappresenta una preziosa testimonianza della vitalità, della densità e della caratterizzazione dei traffici mercantili che all’epoca interessarono i contesti della Calabria tirrenica”. Un tratto di mare decisamente misterioso affollato di relitti nascosti.
Nella mostra archeologica allestita nelle sale al terzo piano del Museo, arricchita dall’innovativo laboratorio virtuale interattivo, MNEME, con reperti risalenti a varie epoche e provenienti per lo più dai siti terrestri e marini presenti nel distretto costiero compreso tra San Lucido e Cirella, troviamo “un esemplare di anfora punica (tipo Ramon T. 4.2.2.7.), recuperata al largo di Cetraro, collegabile probabilmente ad un relitto situato nel tratto di mare tra Paola e Diamante. - sottolinea il direttore - Tipica produzione delle officine di Solunto, nella Sicilia occidentale, di notevole importanza per lo studio dei legami commerciali tra l’eparchia cartaginese e la Magna Grecia, risulta largamente diffusa tra IV e III sec. a.C. in molte aree del Mediterraneo e in Magna Grecia dove veniva utilizzata per il trasporto dei prodotti in salamoia e delle salse di pesce”.
Di recente, sempre grazie a ritrovamenti di pescatori, l’esposizione si è arricchita di due anfore, “entrambe provviste di bollo in cartiglio rettangolare. In particolare - specifica Orsino - si tratta di un esemplare di anfora Dressel di forma 21/22, databile tra I e III sec. d.C., con bollo figulino FE impresso su un’ansa, di produzione campana e deputata presumibilmente al trasporto di pesce salato, in quanto munita di imboccatura larga; e di un esemplare di anfora della famiglia delle cosiddette “brindisina”, prodotta intorno al I sec. a.C., recante su un’ansa un bollo in cui si legge (F)ELIX PVL[LI], relativo alle officine di Felline (Le). Questa tipologia di anfora, dal profilo tondeggiante, veniva solitamente destinata al trasporto di granaglie”.
E’ stato rinvenuto, sempre nello specchio d’acqua antistante la costa cetrarese, e oggi custodito nell’androne di Palazzo Del Trono, “il ceppo d’ancora in piombo del periodo tardo ellenistico su cui è apposto il nome dell’imbarcazione cui apparteneva, E P M H (Ermes), il Mercurio dei Romani, protettore dei commercianti”. Inoltre- per appassionati - al primo piano si può curiosare tra la collezione delle carte geografiche storiche del Fondo Cartografico Losardo, la cui cronologia copre un arco temporale che va dalla fine del 1400 al periodo post-unitario. “Composto da un corpus di carte sia nautiche che topografiche, il fondo risulta di fondamentale importanza per lo studio delle rotte connesse all’antica navigazione ma soprattutto fornisce informazioni essenziali riguardo le trasformazioni subite dal territorio italiano, in particolar modo da quello calabrese”.
Nelle sale espositive si possono ammirare, inoltre, reperti risalenti al IV ed il III secolo a.C riferiti prevalentemente ai Brettii, presenti nel comprensorio. In particolare a Cetraro dove, oltre al rinvenimento di resti di strutture abitative, per lo più fattorie, nel 1996 in località Treselle venne scoperta una necropoli, costituita da un discreto numero di sepolture, precisamente 12, le quali erano apparentemente disposte per gruppi familiari e caratterizzate da due tipologie sepolcrali, alla “cappuccina” e a “cassa” di laterizi. Dal punto di vista delle ricerche, quella di Treselle è considerata attualmente un importante modello di indagine sulle pratiche funerarie relative ai Brettii.
All’interno di Palazzo Del Trono, oltre al Museo, vi è il Laboratorio autorizzato di Diagnostica e Restauro dei Beni Culturali, la Biblioteca Civica, inserita nel circuito Opac SBN e costituita da un catalogo di oltre 40.000 libri, tra antichi e moderni, la sezione dell’Archivio Storico Comunale che contiene la Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Leggi del Regno d’Italia e vari fondi documentali di pregevole interesse.

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736
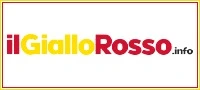









_page-0001.webp)
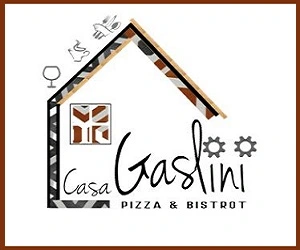



.webp)


