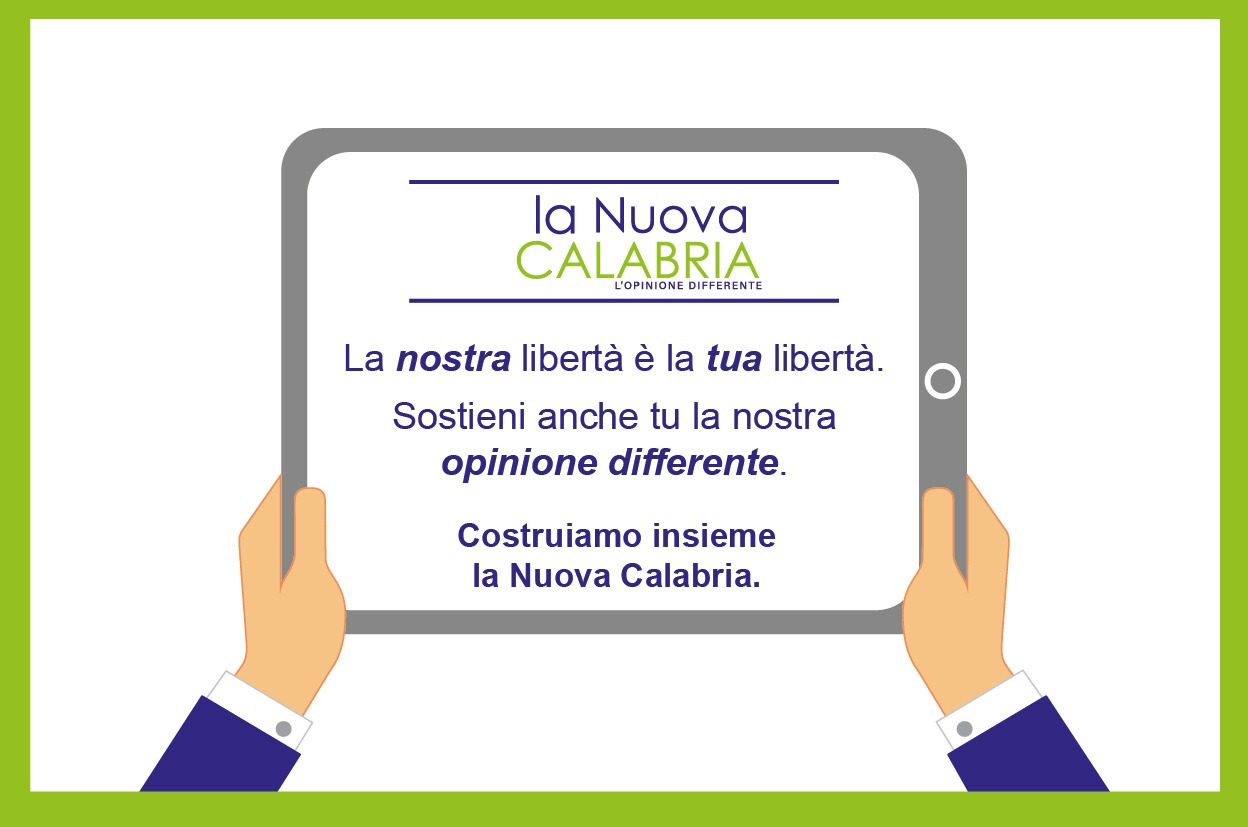L’avvocato Conidi: “Lo Stato che non espelle, le donne che muoiono: il prezzo dell'inefficienza"




04 gennaio 2026 16:33
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA
L’uccisione di una giovane donna per strada, a Milano, da parte di un cittadino peruviano che avrebbe dovuto essere rimandato nel suo Paese e che invece era ancora liberamente sul territorio italiano, avrebbe dovuto occupare per giorni il centro del dibattito pubblico. E invece no. Se n’è parlato poco, troppo poco, rapidamente sostituita da altri temi: il Venezuela, Trump, le solite contrapposizioni ideologiche buone per i talk show. Nel frattempo, una ragazza è morta perché stava camminando. Non perché avesse fatto qualcosa, non perché avesse scelto male, ma perché lo Stato che avrebbe dovuto garantire la sua sicurezza non è stato in grado di farlo.
I dati ufficiali dell’Istat ci dicono che ogni anno in Italia decine di donne vengono uccise e che una quota non marginale di omicidi coinvolge cittadini stranieri in percentuale superiore al loro peso demografico. Questi numeri non servono a criminalizzare nessuno e non autorizzano scorciatoie razziste, ma impongono una riflessione seria su ciò che nessuno vuole affrontare: l’inclusione non è uno slogan, è un processo che produce anche problemi, rischi, responsabilità amministrative precise. Fingere che non sia così è intellettualmente disonesto.
Nel caso di questa ragazza, l’autore dell’omicidio era noto, irregolare, destinatario di provvedimenti di espulsione mai eseguiti. Non è una circostanza marginale, è il cuore del problema. Non siamo davanti a una fatalità imprevedibile, ma all’ennesima dimostrazione di un sistema che produce atti amministrativi senza poi avere la capacità – o la volontà – di eseguirli. Lo Stato italiano non è responsabile penalmente del crimine, ma è legittimo e doveroso interrogarsi sulla sua responsabilità politica e amministrativa, su un’inefficienza strutturale che lascia sul territorio soggetti che non dovrebbero esserci e ignora segnali di pericolo evidenti.
Nel frattempo, sui social network circolano indisturbati video e post in cui uomini, a volto scoperto, minacciano le proprie compagne o ex compagne, parlano di “resa dei conti”, annunciano violenze future. Tutto viene tollerato, normalizzato, archiviato come sfogo digitale. Poi, quando quelle minacce si trasformano in fatti, ci si indigna, si invocano riforme, si parla di emergenza, come se non fosse tutto già stato scritto prima.
Viviamo nel Paese degli spot, dove l’agenda pubblica viene costruita non sulla gravità dei problemi ma sulla loro spendibilità politica. Si parla di inclusione come se fosse un risultato acquisito, una bandiera da sventolare, senza mai affrontare le conseguenze di un’inclusione non governata e senza mai chiamare per nome il vero convitato di pietra: uno Stato inefficiente, lento, incapace di prevenire, incapace di eseguire le proprie decisioni. Parlare di diritti senza garantire sicurezza significa svuotare quei diritti di qualsiasi contenuto reale.
La libertà di una donna di camminare nel proprio Paese senza paura non è un tema ideologico, non è una questione di schieramento, non è una polemica di parte. È il livello minimo di civiltà giuridica. E allora la domanda finale non può che essere questa, semplice e scomoda: se lo Stato non è in grado di far rispettare le proprie regole, di eseguire le proprie decisioni e di proteggere le persone da pericoli noti e prevedibili, di che cosa stiamo realmente parlando quando parliamo di inclusione?
*Avvocato
Segui La Nuova Calabria sui social

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019
Direttore responsabile: Enzo Cosentino
Direttore editoriale: Stefania Papaleo
Redazione centrale: Vico dell'Onda 5
88100 Catanzaro (CZ)
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Sirinfo Srl
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 3508267797