Questi "esami" ci stanno uccidendo: la riflessione di Domenico Bilotti sui continui suicidi




07 marzo 2023 12:36
di DOMENICO BILOTTI
Non passa settimana che non si abbia notizia di studentesse e studenti che compiono atti di autolesionismo, o addirittura si uccidono, per insuccessi scolastico-universitari o, e peggio, ad effetto del senso di frustrazione che quegli insuccessi proiettano nei rapporti con l'ambiente e con la famiglia.
Il dato non è allarmante, è distruttivo. Questi fenomeni, in tutto o in parte, sono forse sempre esistiti, ma la loro crescita quantitativa va di pari passo col loro salto qualitativo. Gli organi di stampa, i media di nuova generazione, le varie televisioni, raccontano tutto ciò in modo molto più preciso e diffuso, e conseguentemente più enfatico, di un tempo. Da un lato, si assiste a una glorificazione altamente pressoria dei risultati eccezionali (superplurilaureati, supergiovani, superdotati, preferibilmente se affetti da diverse abilità: sicché chi ne è portatore ma non è eccellente può continuare a essere considerato un marginale, un mediocre, uno sfortunato). Dall'altro, dal buco della serratura vediamo sempre più in technicolor i drammi dietro gli insuccessi: gonfiati, minacciosi. In altre parole, mostruosi.
È certo segno di maturità saper ricondurre le sconfitte alla ragione: si può sbagliare, si può mancare. Non solo non è un reato, è la sola possibilità di capire cosa cambiare nel proprio percorso, nelle proprie abitudini, nel proprio approccio. E spesso non servono nemmeno scosse telluriche o stravolgimenti, ma caparbio adattamento e genuino ascolto quando si chiede una sponda. Facile a dirsi, si dirà, ma i miei comunque pochi quindici anni di esperienza una cosa me la dicono: facile anche a farsi (e dobbiamo ricordarcelo) quando si capisce il quando e il come. Quello è il lavoro lungo: la comprensione, non il risultato.
Il nostro sistema dell'istruzione si è consegnato mani e piedi agli indicatori di performance. Una scelta tutta politica: la formazione è considerata una torta e l'invito è che occorre darsi gomitate al buffet per poterne prendere una fetta. Il fatto poi che il nostro sistema produttivo si sia scollato così plasticamente da quello formativo è sotto gli occhi di tutti. Nelle città italiane, ad alta o a bassa vocazione turistica che siano, resta sovente uno "scoperto occupazionale" (forse opportunisticamente cavalcato dall'associazionismo di categoria) nelle mansioni più faticose e meno qualificate. Lo dicono a gran voce, addirittura: i lavapiatti, i camerieri, i bagnini, gli intrattenitori. E la nostra economia l'altro grosso scoperto lo ha ai piani alti e altissimi della divisione sociale del lavoro: le professioni altamente qualificate nella gestione amministrativa, nel turismo di qualità, nella ricerca scientifica. Noi tutti abituati al mezzo di un disagevole guado.
I più colpiti sono proprio i giovanissimi, anche perché il flusso di informazioni non offre loro nozioni, rimbombando inevitabilmente (quando la quantità è disorganica) "umori". Si crea la convinzione che ogni piega negativa sia indicatore di un ritardo o di un divario pressoché insanabile da cui dipende la mancanza della pur minima realizzazione. Non è così: le slavine e i ritardi, se non le trasformiamo nell'amaca dei nostri alibi (di cui pure legittimamente potremmo avvertire il bisogno), sono del tutto comprensibili, non sconvenienti, non ineluttabili. Non ci condannano alla serie B del successo -e chi ne misurerebbe la serie A?- ma ci indicano che, si, possiamo essere più rapidi, più svelti, più capaci, e soprattutto che i nostri tempi sono, piaccia o meno, la cosa più autentica che abbiamo a disposizione. Anche quando li subiamo, contengono il seme di una scelta possibile, di una eventualità aperta.
Non è più che una conseguenza la mentalità iper-valutativa nella quale ci stiamo lentamente emergendo. La causa è che ci è stato proposto un modello di quantità oggettive e irrilevanti e di qualità opinabili e determinanti: più facciamo e meglio è e la meritevolezza di ciò che facciamo dipende sempre e solo da criteri che non contribuiamo a decidere. Così riguardata, l'ansia è un problema di democrazia.
Persino nei nostri momenti di svago, siamo diventati pallottolieri di una prestazione: la "malamovida" troppo spesso utilizzata per contrarre spazi di libertà e inasprire conflitti altrimenti risolvibilissimi è l'effetto inevitabile di un clima che impone di non fermarsi quando si è nel mezzo del tutto. Invece quanto conta la serenità di ciò che si sceglie!
Uno dei nostri più grandi scrittori, Calvino, invitava a riconsiderare la lievità: la grazia di poter essere leggeri, l'opportunità irripetibile di non saturare di un tutto ingordo e carnivoro ogni nostro momento di vita. La lievità così concepita non è la superficialità, l'ipocrisia, il trascinamento. È invece l'essere complici e non competitori. Disponibili, non sciocchi. In dialogo, non chiusi. Fragili, non finti. Solidi, non gonfi.
Nel piccolo, l'università di Catanzaro sa e sempre più saprà che proprio la virtù dei nostri numeri di prossimità migliora le relazioni, coagula le gerarchie, attutisce gli spigoli. Si porge a un percorso in cui tutti siamo immaturi e non certo per restarci, ma per potere crescere assieme.
Non crediamo alle sirene, che sono comunque molto più tollerabili delle gride con cui si metteva la taglia sui bravi di Manzoni. L'università non è né la prosecuzione del liceo con altri mezzi (anche se faremo una riflessione su come l'università rischi di liceizzarsi e su come i licei non riescano spesso più, non certo solo per loro demeriti, ad avere un ruolo e una posizione nella società in cui esistono) né l'anticamera di un lavoro fatto e finito, già assegnato, già esistente, da dovere prenotare con ansia, menefreghismo o indifferenza.
Altrimenti questi "esami", questa mentalità invalsa di sezionarci a pezzetti, di non potere mai essere né collettivo né persona singolare, avranno un solo risultato: ucciderci.
Non siamo allevamenti intensivi di maiali. Siamo persone che sbagliano: contro la logica della pretesa e quella dell'aspettativa, che ci ringhiano a pochi passi, scegliamo la logica dell'essere finiti e finitimi. Fallibili e vicini. E chissà così davvero non si vinca.

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736
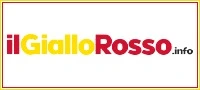








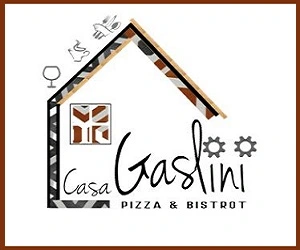
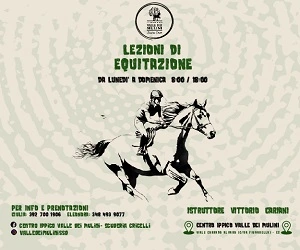
.webp)





