San Vitaliano tra il sacro e il profano in una una ricerca di Francesca Rizzari




09 luglio 2025 18:01
Catanzaro entra nel vivo della settimana che ci porta alla tanto attesa Festa di San Vitaliano, il Patrono della gloriosa Città dei Tre Colli . Una ricorrenza avvertita al di là di ogni barriera fideistica. Per onorare la ricorrenza del Santo è stato approntato, infatti, un vasto programma di avvenimenti. Che avranno il loro culmine nella Processione del Santo. San Vitaliano quindi tra il sacro e il profano.
Per la circostanza la professoressa Francesca Rizzari ha trovato nel suo archivio una significativa e dotta ricerca dal titolo emblematico – San Vitaliano tra il sacro e il profano- della quale vi proponiamo di cui vi proponiamo la lettura.
Le tensioni politiche e l’accentuarsi del particolarismo favoriscono l’affermazione dei Normanni, soldati mercenari giunti dal nord, i cui servigi vengono compensati con la contea di Aversa in Campania e il ducato di Melfi in Puglia. Grazie alla loro tenacia, dopo secoli di disgregazione il Meridione riesce ad avere una dominazione unitaria, caratteristica del futuro percorso storico e un sistema feudale. Il Papa vede in essi una forma di protezione mentre questi a loro volta necessitano della legittimazione della Chiesa per assumere un ruolo egemone sul territorio. Il rito liturgico greco dà posto a quello latino.
La città di Catanzaro, sita in un luogo elevato facilmente difendibile dagli attacchi saraceni, è protetta dalla rocca sovrastante e dalla cinta di mura di cui permangono tracce di bastioni. Il centro abitato è caratterizzato da case di legno o di creta o di paglia e da poche in muratura, proprietà quest’ultime dei nobili; è difficile separare la zona abitata da quella rurale in cui si coltivano alberi da frutto (fichi, agrumi, fichi d’India) e soprattutto il gelso per la nascente industria serica che richiama ebrei e altri orientali a commerciare.
Papa Callisto II, che passerà alla Storia per aver stipulato a Worms (Franconia renana) con l’imperatore Enrico il concordato col quale si pose fine alle lotte delle investiture dei vescovi-conti e quindi alla separazione ufficiale dell’autorità spirituale da quella temporale, nello scendere nel meridione per fare da paciere tra i Normanni di Puglia e quelli di Sicilia (“causa componendae pacis inter ducem Wilhelnum et comitem Rogerium Siciliae”) e per trasferire l’arcidiocesi da Taverna a Catanzaro, porta nella nostra città le reliquie di Vitaliano, 25° vescovo di Capua, deponendole accanto a quelle di Ireneo di Lione e Fortunato di Todi, ritrovate poi tutte nella cappella del Duomo nel 1583.
Non si hanno notizie certe se ci fosse una chiesa madre preesistente, alcuni storici asseriscono se ne trovasse una dedicata a San Michele dove oggi sorge il Palazzo della Camera di Commercio. Fu il conte Goffredo di Loritello a costruire il nuovo Tempio all’Assunta la cui bolla, non l’originale che fu distrutta nell’incendio del 1660, è scolpita in marmo in una lapide muraria ancora visibile. Certamente lo schema costruttivo del tempio a croce latina in stile romanico a tre navate con transetto e varie cappelle, di cui una per il protettore e il campanile sul lato sinistro. Il sito scelto è al centro della città.
La cattedrale nel corso dei secoli fu più volte distrutta da incendi e terremoti e più volte rimaneggiata. Nel XIX secolo il vescovo De Franco si rivolse all’ingegnere architetto Michele Manfredi, progettista dell’unico piano regolatore cittadino, a dare una degna e solida sistemazione architettonica a tutte le chiese della città, comprese quelle di Gagliano, e alla Cattedrale, alla quale, oltre al rifacimento della facciata esterna, fu aggiunto il bel campanile per collocare le cinque campane preesistenti, poi raso al suolo dai bombardamenti del 1943. I lavoratori contribuirono con una giornata di paga alla sistemazione della base per il busto argenteo del XV secolo e fu rifatto dalle fondamenta il palazzo vescovile.
La biografia di San Vitaliano di Capua è un misto di verità e leggenda. Le notizie attendibili sono date da un codice in pergamena del XII secolo rinvenuto da monsignor Stefano Borgia nella Chiesa di Benevento.
Vissuto nel V secolo, Vitaliano fu eletto vescovo per acclamazione dal popolo sebbene malvisto e perseguitato da molti nemici. Fu accusato di atti impuri perché usciva di notte vestito di indumenti muliebri, i suoi sostenitori lo appoggiavano asserendo che con quelle vesti si dedicasse alla beneficenza clandestina. Il prelato abbandonò la diocesi per avviarsi a Roma dal Papa ed esporre la verità, tuttavia raggiunto lungo il cammino, fu rinchiuso in un sacco di cuoio e gettato nelle acque del fiume Garigliano. Dio volle che venisse raccolto vivo lungo la battigia del mare di Ostia. La cittadina di Capua veniva intanto colpita dalla punizione divina con carestia, peste e siccità. Quando il vescovo tornò tra la sua gente, miracolosamente una pioggia provvidenziale alimentò le piante stecchite e le calamità si placarono. I fedeli lo invogliarono a riprendere la carica episcopale, ma con un deciso rifiuto preferì dedicarsi alla preghiera nella solitudine. La vita ascetica lo avrebbe allontanato dalla miseria umana e avvicinato a Dio. Si rifugiò così sul monte Partenio tra i ruderi di un tempio pagano. Su questo monte, che per una cappella dedicata alla Vergine si chiamò Montevergine, tre secoli dopo San Guglielmo da Vercelli fondò un monastero dove custodire le reliquie di Vitaliano, che furono poi trasferite a Benevento e infine a Catanzaro.
Non sempre le notizie tramandate sono concordi, tanto che il Santo viene ricordato in due date: il 3 settembre a Sparanise e a San Vitaliano (paesini della Campania) e il 16 luglio a Catanzaro, che ne festeggia il patrocinio la domenica in albis a ricordo del terremoto del 1806.
I Catanzaresi hanno profondamente interiorizzato la figura del loro protettore contornandola di leggende e credenze mistiche. Il fatto, ad esempio, che il busto argenteo non abbia le braccia è stato interpretato come prova della leggenda secondo cui al Santo, prima di finire nelle acque del Garigliano, avessero amputato gli arti; dalla lucentezza del suo manto si prevedeva invece l’andamento dell’annata.
Fino agli anni ’50 del XX secolo, in occasione della celebrazione del Santo, durante la processione, che seguiva lo stesso itinerario di quella del Corpus Domini con tutti i sacerdoti dell’arcidiocesi, la statua veniva portata a spalla esclusivamente dai canonici, altrimenti il peso sarebbe stato insostenibile, ma in seguito, a causa dell’età avanzata dei religiosi, si ricorse ad un camioncino adorno di fiori.
Si dice ancora che la statua sudasse manna e che il suo sguardo “sdegnato” voglia smuovere i cittadini dalla pigrizia.
Il Santo era venerato dai forestieri, amalfitani soprattutto, che si stabilivano in città per dedicarsi al commercio di generi alimentari a discapito dei poco intraprendenti abitanti del luogo. Da qui il detto: “San Vitaliano protegge i forestieri”.
San Vitaliano non ha mai abbandonato i suoi fedeli nei momenti più difficili, a Lui si attribuiscono molti miracoli. Catanzaro fu risparmiata dall’incendio divampato per volontà del Centeglia (XV secolo) quando cercò di farla capitolare: improvvise raffiche di vento allontanarono le fiamme dall’abitato senza provocare ulteriori rovine. Già da allora nelle fiere si vendeva il fischietto di terracotta rappresentante il busto del Santo (“’cchi frisca do culu”).
San Vitaliano protettore della peste veniva effigiato nelle icone dei muri delle case per salvaguardare le famiglie (usanza poi abolita nel XIX secolo almeno per le abitazioni del corso principale).
Carlo III di Borbone (poi re di Spagna) nel 1735 in visita a Catanzaro ebbe in dono dall’allora vescovo Rossi un reliquiario con un molare e un frammento di ossa del nostro protettore. Il sovrano cambiò itinerario e, proprio nella stanza in cui sarebbe dovuto pernottare a Maida, crollò il soffitto. L’accaduto fu interpretato come il monito del nostro Santo, che non vuole allontanarsi da questa terra.
Di recente, la signora Rita Caroleo di Gagliano, sottoposta a un intervento chirurgico a Monza, asserisce di essersi svegliata dall’anestesia per continue scosse sismiche. Si è saputo poi che il figlio le aveva posto sul comodino l’immaginetta del Santo, che sarebbe dovuta invece rimanere a Gagliano.
Nicola Gualtieri, brigante noto come Panedigrano, seguace di Fabrizio Ruffo, il 26 luglio del 1800 giungeva con l’idea di saccheggiare la città qualora non avesse ricevuto un riscatto di un milione di ducati. Vane furono le suppliche dei notabili e del popolo, ma il malvagio nel varcare la Porta di mare si sentì tirare dai capelli proprio da quel vescovo effigiato sulla porta. Si accontentò di poco e mutò atteggiamento.
Nel 1856 dopo un’ondata di colera il confratello Antonio della nobile famiglia Arceri fece dono alla chiesa dell’Immacolata di una statua del Santo. Il busto porta in testa la mitra in seta ricamata con oro fino e pietre, la mano sinistra con il baculo pastorale dorato e in basso su un pezzo di tavola un poco concava è dipinta la città.
I Catanzaresi hanno sempre ringraziato il Protettore per i danni meno gravi subiti rispetto all’entità dei continui terremoti che si sono verificati nel corso dei secoli. Al primo movimento sismico è spontanea l’invocazione: «San Vitaliano salvaci!».
Nel secondo conflitto mondiale la famiglia Lucà dei baroni di Poerio, proprietaria di un palazzo in via XX settembre, prima di riparare altrove, nell’abbandonare il caseggiato lasciò affisse al portone le immagini di San Vitaliano e della Madonna del Carmine. Il bombardamento, che colpì e distrusse gli edifici circostanti, lasciò indenne l’abitazione dei Lucà. Miracolo!
In passato la festa del nostro protettore era attesa e sentita, la data dava inizio al mese dei bagni alla marina, perché fino a quel giorno l’acqua del mare avrebbe dovuto assorbire il calore del sole. La popolazione partecipava alla processione e dalle finestre si esponevano i damaschi di seta giallo oro o cremisi tessuti in loco, con i disegni a foglia di alloro, di ulivo o di acanto. Gli uomini portavano per ornamento le zagarelle, nastrini di seta di tutti i colori che venivano benedetti facendoli passare sulle labbra della statua per metterli all’occhiello della giacca o come braccialetto ai polsi dei bambini. Dopo la demolizione del vecchio teatro, la sera fino a tardi si esibivano sul palco cantanti lirici di grido per soddisfare le esigenze raffinate di un pubblico competente. Essendo giorno di festa finalmente si poteva stare a tavola e godere di un buon pranzo: pasta piena, cotolette con contorno di patate e peperoni e la classica parmigiana di zucchine. I giornali di fine ‘800 annotano il mercato di animali a via Indipendenza e ancora il ballo dei bambini in villa Margherita organizzato dalle dame di Carità. La sera musica a teatro e illuminazione straordinaria. Sempre offerti dalle dame si sorteggiavano due maritaggi per ragazze oneste orfane e 110 camicie per i poveri.
Alla fine della guerra, poiché le case erano anguste, si tentava l’usanza di festeggiare i fidanzamenti proprio il 16 luglio sulla spiaggia. Alla fine del banchetto accadeva spesso, col dispiacere degli astanti, che il grosso cocomero (‘u zoparrucu) lasciato al fresco dell’onda del mare non si trovasse più. Se l’era portato il Santo e come Lui sarebbe ricomparso in altro lido.
Oggi la festa ha più che altro valore religioso, poco diffuso il nome Vitaliano con i diminuitivi Talianu e Talianeddhu o Liano, nei tempi più moderni. Molta gente è emigrata, altra è venuta da altri paesi, la situazione economico-sociale è mutata, è tempo di vacanza e quindi di lasciare la città. Non si allestiscono le luminarie, tuttavia si cerca di rinvigorire la devozione. Permane la tradizionale Messa solenne con la presenza del Sindaco per implorare la benedizione della città.
Si è cercato negli ultimi anni di stabilire un rapporto con la chiesa di Capua. Nel 1992 è venuto Padre Franco Tamburrino abate di Montevergine e nel 1998 monsignor Bruno Schettino, vescovo di Capua, ha concelebrato la Messa in Cattedrale.
Al Patrono è stata dedicata la chiesa del cimitero e ancora la statua all’ingresso.
Occorre consolidare il culto, la città non può lasciar affievolire la devota riconoscenza a Colui che le ha risparmiato tante disgrazie. Bisogna conoscere il passato per capire il presente e costruire il futuro.
«Lex orandi, lex credendi». San Vitaliano è la nostra storia e lo conferma il motto delle tre V: vento, velluto e Vitaliano.”

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736










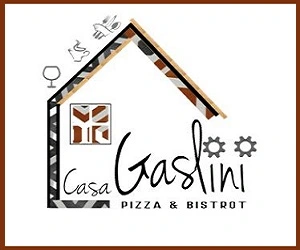



.webp)


