Vanni Clodomiro: “La Resistenza”




25 aprile 2025 08:00
di VANNI CLODOMIRO
Premessa necessaria a qualsiasi discorso che riguardi in qualche modo il fascismo è un cenno al suo carattere europeo. Oltre all’Italia, la Francia, la Spagna, la Germania e altre nazioni furono, più o meno simultaneamente, infettate da quel tremendo virus che fu il totalitarismo. Ma diciamo che il fascismo italiano e il nazismo tedesco furono le espressioni più cospicue di quel vasto fenomeno che investì l’Europa nella prima metà del nostro secolo. Ma aggiungiamo che carattere decisamente europeo ebbe anche la Resistenza.
Durante il secondo conflitto mondiale, le condizioni dei popoli conquistati generarono odio contro il nazismo – che ormai impersonava più e meglio del fascismo il totalitarismo –e ciò diede origine, prima, ad un coperto movimento di opposizione politica, e poi di aperta lotta militare che fu laResistenza. Da noi, la Resistenza al fascismo e a tutto ciò che esso rappresentava si cominciò ad organizzare fino dal 1941. Nel biennio successivo si costituì la Resistenza dei Comunisti, i quali volevano un rinnovamento totale dell’organizzazione della società, ispirato al modello sovietico di Lenin e Stalin, anche se il loro richiamo teorico si riferiva direttamente a Marx ed Engels: le loro brigate si chiamarono Garibaldi.
Bisogna precisare subito che i Comunisti costituivano il partito meglio organizzato di tutta la Resistenza. I Socialisti, sempre divisi (fin dall’epoca della prima guerra mondiale) in riformisti e massimalisti, si caratterizzavano, ovviamente, per la minore coesione interna, il che non facilitava certo il compito, in sè già molto difficile, della Resistenza. Tra la fine del 1941 e il gennaio 1942 appare un nuovo Partito d’Azione (il cui nome si ispirava al vecchio Partito d’Azione di Garibaldi). Il Partito d’Azione traeva la sua origine da Giustizia e Libertà, un movimento fondato nel 1929 a Parigi dai fratelli Carlo e Nello Rosselli – esuli a causa del fascismo – i quali sostenevano la forza della volontà dell’uomo contro il fatalismo involontaristico del marxismo. Altro grande intellettuale, cui si ispirò il Partito d’Azione fu Piero Gobetti, un democratico purissimo, e fondatore e direttore della Rivista «Rivoluzione Liberale». Tra i fondatori del Partito d’Azione vi furono anche, Emilio Lussu, Ugo La Malfa, Carlo Azeglio Ciampi e altri importanti intellettuali, e le brigate di questo partito furono denominate appunto Giustizia e Libertà. E qui bisogna precisare che il movimento cui il Partito d’Azione si ispirava seguiva quella particolare tradizione di intransigenza morale e politica di chiaro stampo mazziniano, che rimase a lungo nella cultura politica italiana. Fu comunque un partito d’élite, e per questo non ebbe molta presa sulle masse. Inoltre, era caratterizzato da una sorta di contraddizione ideologica della quale non riuscì mai a liberarsi: propugnava i due valori fondamentali della giustizia sociale, di derivazione socialista, e della libertà individuale, di derivazione liberale: in sostanza, il Partito d’Azione intendeva conciliare le opposte esigenze del collettivismo socialista e dell’individualismo liberale. Impresa concettualmente molto ardua e comunque contraddittoria, tant’è che l’insanabile contrasto ideologico rimase – fino allo scioglimento del Partito, avvenuto nel febbraio del 1946 – il tarlo roditore di una formazione politica generalmente animata da grandi temi e capace di impegnarsi a fondo in grossi dibattiti politici e intellettuali.
Ad ogni modo, nell’ambito della Resistenza, svolse un ruolo di primo piano e si caratterizzò principalmente per la lotta alla monarchia, disprezzata profondamente anche dal punto di vista morale, in quanto, nel momento in cui aveva temuto molto per sè, non aveva esitato a gettare in mare Mussolini per salvare se stessa.
Altre formazioni della Resistenza furono la DemocraziaCristiana e il Partito Liberale, sostanzialmente conservatori etenaci sostenitori del regime democratico monarchico del periodo precedente al fascismo, senza rendersi conto che l’Italia prefascista non era – e d’altra parte non poteva essere –quella del ’43. Il concetto di democrazia moderna, venuto fuori dall’ambiente antifascista della Resistenza era del tutto dissimile da quello monarchico, liberale e giolittiano del primo ventennio del ’900. La democrazia era, in effetti, solo una forma di governo, ma, nella sostanza, è noto a tutti che di autenticamente democratico c’era poco o nulla nell’Italia prefascista. Invece, fu proprio con la Resistenza che il concetto di democrazia si riempì di un significato molto simile a quello che noi oggi siamo soliti attribuirgli.
Nel 1943 si verificano scioperi di chiara protesta antifascista. La monarchia sentì vacillare il proprio trono e si risolse (troppo tardi!) al colpo di Stato del 25 luglio. Nel corso di una tempestosa seduta del Gran Consiglio, in seguito ad una mozione di Dino Grandi, il Re licenziò Mussolini e nominò Capo del Governo il maresciallo Badoglio: governo di ispirazione antifascista e di impegno a restaurazione democratica (non si può onestamente negarla al primo Governo Badoglio), ma governo di emergenza, non frutto di elezione popolare. In seguito però i governi, pur nominati Capo dello Stato, furono fondamentalmente emanazione dei partiti collegati nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN).
Il licenziamento di Mussolini, preparato attraverso un lungo lavorio degli antifascisti, testimonia la rottura tra il fascismo e la Nazione. L’8 settembre dello stesso 1943, gli alleati comunicavano via radio l’armistizio firmato con l’Italia il 3 settembre. Per l’immediata reazione dei tedeschi, che occuparono quasi tutta l’Italia, il Re e Badoglio si rifugiaronoa Brindisi, che era stata subito occupata dagli alleati, e colà ebbe sede il governo.
È utile qui ricordare un fatto molto significativo e importante: il generale Castellano, in rappresentanza dell’esercito italiano, era giunto a Lisbona la sera del 16 agosto, ma poté trattare solo alcuni giorni dopo con il generale Smith, capo di Stato maggiore del generale Eisenhower. Il rappresentante italiano offrì, oltre alla resa, la piena disponibilità ad agire secondo un piano comune, in modo da scacciare i tedeschi dall’Italia al più presto. Chiese soltanto che il governo italiano fosse tempestivamente messo al corrente della data in cui si sarebbe dovuto dare l’annuncio ufficiale dell’avvenuto armistizio, per evitare all’esercito il panico e la disgregazione dovuti a mancanza di istruzioni operative. Ma neanche questo si ottenne e il maresciallo Badoglio fu informato che l’armistizio stava per essere annunciato al mondo soltanto poche ore prima delle 18.30 dell’8 settembre, l’ora cioè che il generale Eisenhower aveva stabilito per tale annuncio.
Il 21 settembre, Churchill dichiarò:
«Avremmo fatto di più se fosse stato possibile per aiutare questo infelice Governo che era assillato da ogni parte da problemi insolubili e che da allora ha agito verso di noi come meglio poteva, con coraggio e in buona fede».
A quel punto, era chiaro che la simpatia alleata, specie inglese, per la corona italiana avrebbe in seguito facilitato inevitabilmente anche il riconoscimento delle forze partigiane, che comunisti ed azionisti erano stati i primi ad organizzare. Infatti, quelle forze erano guidate dai partiti del CLN, che sarebbero entrati poi a far parte dei vari governi, a cominciare dal secondo di Badoglio.
Intanto, il 18 settembre, Mussolini costituiva a Salò quella Repubblica Sociale Italiana che tanti guai avrebbe procurato a tutta la Nazione, per l’asprezza della lotta tra fascisti e antifascisti che ne conseguì.
Nel gennaio del 1944, si tenne a Bari un famoso Congresso del CLN, che chiese l’abdicazione del Re, ma il vecchio saggio Benedetto Croce fece notare che Churchill non aveva certo nascosto le sue simpatie per la Corona: perciò lasituazione diveniva abbastanza confusa. Senonché, giuntoTogliatti dalla Russia, dichiarò di accettare la soluzione di compromesso prospettata da Croce e De Nicola, per cui il Re si impegnava a rimettere i suoi poteri al figlio Umberto, nominato Luogotenente, al momento della liberazione di Roma: si rinviava così la questione istituzionale alla fine della guerra. E così Togliatti otteneva di rendere impossibile mettere da parte il Partito Comunista nelle strategie politiche di quel momento. Tale conclusione non deve comunque sorprendere, in quanto, se la Repubblica di Salò era notoriamente un governo fantoccio nelle mani dei tedeschi, in fondo lo era anche quello di Brindisi, che non si poteva quindi permettere di contrastare Churchill. Nell’aprile successivo, per iniziativa di Togliatti, era stato operato un profondo rinnovamento nel governo Badoglio, trasformato con la partecipazione dei partiti antifascisti, con la sola eccezione dell’intransigente Partito d’Azione, che non aveva voluto entrarvi, ritenendo il Badoglio compromesso con la monarchia.
Intanto, con la collaborazione dei partigiani, gli Alleati avanzavano. La Resistenza entrava così nella sua fase più piena: a giugno, con la liberazione di Roma, ad agosto con quella di Firenze. Si intensificavano colpi e sabotaggi e si creavano zone libere.
Nella notte tra il 24 e il 25 aprile 1945, i partigiani,sostenuti da un ampio movimento di resistenza popolare, organizzarono attacchi contro le forze nemiche, occupando strategici punti chiave nelle città, mentre la popolazione civile si unì alla lotta di liberazione – che culminò nei giorni successivi – portando alla presa di Milano e di altre importanti città italiane.
Contrariamente a quanto qualcuno si ostina a sostenere, laResistenza non fu effimera: al contrario, fu un validissimo aiuto per gli Alleati. Dal settembre ’44 all’aprile ’45 il movimento resistenziale visse dieci mesi durissimi: sono di quel periodo le rappresaglie tedesche contro i civili.
Nell’autunno del ’44, la Resistenza attraversò una crisi politica, per la disparità di vedute nel CLN, a proposito della sorte della monarchia e quindi della questione istituzionale. Vi furono anche gravissime perdite, ma la crisi venne superata, nell’intento di combattere il nemico comune. Il 9 aprile 1945 gli Alleati entrarono a Bologna e il 25 aprile giunsero nella pianura padana; il 28 Mussolini fu catturato a Dongo (Como) e fucilato dai partigiani.
Forte dell’azione svolta per favorire l’avanzata degli Alleati, il CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) trattò con essi con autorità, tanto da poter prendere l’iniziativa di ordinare l’esecuzione di Mussolini.L’impiccagione della sua salma a Milano – che fu comunque un episodio deplorevole – volle significare la definitiva rottura dell’Italia con il suo passato di sostegno al fascismo.
La Resistenza si proponeva un mutamento radicale, ma le forze della conservazione, coadiuvate dai cattolici, avrebbero poi trovato il modo di ottenere il maggiori consensi con la Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi.
Il 2 maggio del 1945 Hitler si suicidò, e il 10 maggio la Germania dovette finalmente arrendersi senza condizioni.
Ora, traendo a conclusione il discorso, bisogna dire che la Resistenza valse a mantenere salda l’Unità e l’indipendenza dell’Italia, mentre la Germania rimase sotto l’occupazione alleata. Inoltre, vogliamo sottolineare un fatto importante, e cioè che la Resistenza rappresenta un legame e una continuità ideali tra la lotta per la libertà nel Risorgimento e nel periodo della seconda guerra mondiale. Con una differenza: che, nel Risorgimento, il movimento libertario era stato appannaggio di pochi, mentre nella Resistenza si lascia coinvolgere una gran massa di cittadini, non solo intellettuali, ma anche operai e contadini. Non solo, ma è necessario ricordare che vi parteciparono, combattendo e dando anche la vita, molti stranieri: russi, slavi, africani, e perfino quei tedeschi che, anche per ragioni ideologiche, vollero combattere il nazismo. E non un contributo irrisorio: si tratta almeno di quindici ventimila uomini.
Accanto alla Resistenza armata, fu incisiva la Resistenzapolitica, che impedì la restaurazione della monarchia e portò al Referendum del 2 giugno 1946. Già all’indomani del colpo di Stato del 25 luglio, il mazziniano Duccio Galimberti ebbe modo di dire che il popolo italiano si ribellava contro la tirannia mussoliniana, ma non si accordava ad un’oligarchia che cercava di salvare comunque se stessa a spese degli italiani.
Oggi, chi assiste, ad ottant’anni di distanza, allo scempio che quotidianamente si fa della Resistenza a scapito di formule politiche di nuova invenzione e a beneficio di vecchie logiche fasciste, ha il dovere di dire NO!, proprio per rispetto della Resistenza con la R maiuscola; perché la lotta di liberazione e di affrancamento dalla dittatura si sottrae a qualsiasi facile schematismo. A quella lotta sanguinosa si deve l’ultima possibilità di espressione democratica della nazione italiana. Quindi, questo è un patrimonio politico e culturale che non può e non deve assolutamente essere sciupato. Vogliamo piuttosto sperare che, rientrati i nuovi farneticamenti che sembrano emergere nella società in questi ultimi tempi, gli italiani possano continuare il cammino di una democrazia vera (di cui tutti parlano, persino i fascisti), senza quella violenza che oggi sembra riemergere in frange non più tanto piccole della nostra società. E che Papa Francesco ha sempre indicato come segno di inciviltà.

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736










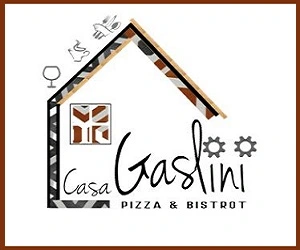



.webp)


